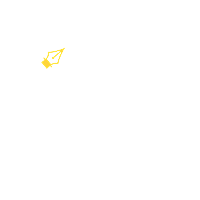Beati gli orbi
“
“Ora affronterai il mare delle tenebre, e ciò che in esso v’è di esplorabile”.
Fulci, …e tu vivrai nel terrore! – L’aldilà (1981)
Un fattoide che devo aver letto in qualche rivistaccia di psicologia dice che nelle condizioni di emergenza, gli unici a non entrare nel panico sono i depressi gravi. Si può dire lo stesso dei ciechi quando va via la luce. O, nel nostro caso, quando hanno perso la vista tutti, tranne quelli che già non l’avevano. Ora io non ho mai amato Saramago, quindi quando i gallu sono venuti a bussare alla mia porta, in quegli anni di orrore in cui diventammo tutti ciechi, se non altro avevo le idee chiare su che libri non portarmi dietro.
Vado ad aprire, e sento due presenze alte e orribili davanti a me.
«Manuele Coarelli», dice il primo.
«Sono io».
«La portiamo nel Kur».
«Può vestirsi con calma», precisa il secondo. «L’aspettiamo qui».
«Posso palparvi? Non tutti e due, basta uno».
Silenzio.
«Per curiosità, mica per altro».
Silenzio. Poi:
«Va bene».
Uh-uh, cosa palpano queste mie mani. Una creatura alta più di me, il becco dell’aquila, torace come un armadio e altrettanto solido, due ali da pipistrello che stanno piegate dietro la schiena, un occhio solo ben tondo e –
«Di che colore avete gli occhi?»
«Azzurri».
Lo sapevo. Non che per me abbia senso, però me lo sentivo. Associo da sempre l’azzurro, qualunque cosa esso sia, a gente fredda e crudele.
«Signor Coarelli».
«Va bene, va bene. Mi vesto».
Eseguo, metto nello zaino i miei braille e il bastone pieghevole, e vengo portato a braccetto giù nel Kur. Camminiamo per una mezz’ora nel viale davanti a casa mia. Sento la primavera sulla pelle, l’odore marcio del gingko, ma qualcosa non va nei rumori – c’è un silenzio tombale. O sono tutti fermi immobili a guardarmi scortato, ma non credo, o sono già tutti nel Kur e io sono l’ultimo. Gli artigli del piede tridattilo dei miei compagni producono un clic-clac sull’asfalto che mi ricorda quello delle suole delle mie scarpe di vernice nera o i tacchi della mamma di Lavinia quando andavo al liceo, toc toc toc, buongiorno Manuele (e mi dava un bacio sulla guancia). Il giro che fanno i gallu è talmente tortuoso che, per quanto io conosca il mio quartiere da trent’anni e lo abbia girato tutto, non capisco dove siano queste scale che stiamo improvvisamente scendendo. E le scendiamo per un bel po’. Non sono le scale definitive, quelle che quando arrivi al fondo sei nel Kur. Si interrompono anzi più volte, e mi ritrovo a percorrere il pavimento di una stanza chiusa, poi giù di nuovo per altre scale; poi porticine che si aprono e altri metri su materiali che dal suono mi paiono gres porcellanato, legno e infine pietra; e ancora scale. Sono ripide e strette – non riuscirei a mantenere questo ritmo se non fossi scortato dai due gallu che mi tengono a braccetto e quasi mi sollevano mentre cammino. Sento odore di pietra, pietra fresca. Siamo al chiuso, sempre più al chiuso, ma in qualche modo non cedo alla sensazione di strozzamento perché l’aria non è secca né stantia, sento anzi un ineludibile venticello freddo che viene dal basso. Sotto il rumore di due suole e sei artigli sulla pietra, se mi concentro – e tempo ne ho, scendiamo forse per un’ora – si fa strada sempre più forte il rumore di acqua corrente. E assieme a lui, il chiasso delle voci umane.
«I disabili li avete fatti per ultimi?», chiedo.
«Sì. Per ovvie ragioni», risponde uno.
Improvvisamente il sospetto:
«Posso tenere la mia roba, vero? Il bastone e i libri in braille».
«Che domande fa», risponde l’altro.
Meglio non irritarli, tanto fra cinque minuti spariranno dalla mia vita. Se ho capito bene. O ce li ritroveremo anche nel Kur a montare la guardia? Dio, spero di no. Ma la guardia a chi, poi? Da laggiù dove cazzo andiamo? E mentre penso ancora in termini di laggiù, atterro sull’ultimo gradino e laggiù diventa qua.
«Noi di solito ci fermiamo qui. Riesce a continuare da solo?», chiede uno.
«Sì».
«Va bene. Le sue scarpe, signor Coarelli».
«Eh?»
«Le scarpe. Nel Kur si va a piedi nudi».
«Perché?»
Il secondo mi tiene fermo mentre il primo mi leva le scarpe.
«Buona fortuna e non faccia sciocchezze».
Si dileguano risalendo le scale, toc toc toc. Mi concedo un attimo di panico – un secondo di orrore assoluto, in cui la mia mente viaggia nel tempo, copre i prossimi venti, trenta, cinquant’anni, e l’eternità che mi aspetta finché non riuscirò, misericordiosamente, a morire (sempre che quaggiù si muoia mai: i gallu non sono stati chiari in proposito). Ma è solo un attimo, perché sono cieco dalla nascita e ho sempre avuto poco tempo a disposizione per la paura. Al toc toc toc degli artigli dei gallu faccio seguire il tlac! del mio bastone che si apre. Lo poggio a terra, ed eccomi operativo.
Non è poi una situazione tanto diversa da quando, tanti anni fa, i miei mi portavano alle feste con mezz’ora di anticipo, per farmi esplorare il posto con calma e non farmi prendere in contropiede all’arrivo degli altri invitati. Col movimento a ventaglio del braccio che faccio senza pensarci e il passo prudente di chi si aspetta merda, vetri rotti, vomito o ghiaccio appena fa un metro sul marciapiede, avanzo sul pavimento del Kur. Al tatto, la superficie è pietra liscia, gobbuta qui e lì, e umida; l’aria è fresca ma non gelida, come negli androni dei condomini dove andavi a sederti d’estate per scappare al caldo. E questo rumore di corrente non mi frega, sono vicino a una fonte d’acqua. Annuso l’aria e agito le mani sopra di me. Un po’ l’eco del bastone, un po’ quest’aria sopra e intorno a me, e i rumori di cui triangolo diecimila fonti diverse, mi suggeriscono l’immensità di questo posto. Sono all’interno di una caverna sotterranea di proporzioni ciclopiche. Molto ma molto sopra di me si sente l’eco del suono delle acque e le voci delle persone. In che direzione sono? Da qui non capisco, troppo lontani. Ed ecco che il bastone tocca duro. Sono arrivato alla parete della caverna. Ancora più liscia del pavimento – se l’annuso, mi pare che sappia di porcellana e smalto per unghie. In alcuni punti pare proprio lucida. Procedo finché non metto il piede nell’acqua.
Se dovessi determinarne la temperatura, non saprei bene come esprimermi. Pare variare a seconda di come oriento il piede. Ora sembra fresca, ora tiepida. È anche possibile che i gradi crescano e calino a intervalli casuali. Comunque il fondale è basso, è un canale stretto e poco profondo – le rive sono perfettamente lisce, direi quasi angolari – che tramite una specie di cunicolo porta ad un’altra caverna, da cui arriva solo il suono dell’acqua, ma nessuna voce umana. Torno a costeggiare la parete della caverna da cui provengo e finalmente mi pare di andare nella direzione delle voci. Troppo entusiasmo; la punta del bastone non tocca terra, mi sbilancio, finisco in acqua fino alla cintola. Questa è una piscina, non è un canale – una vasca, diciamo meglio; avanzo a tentoni fino alla riva, e dall’odore mi pare di capire che i primi corpi sono a pochi metri. C’è sudore, vampate e ormoni – c’è anche molta paura.
«Zitto, che è questo sciacquio»
«Oh cazzo ne arriva uno»
«No no cosa dite, non è un gallum, ehi scusi, chi è là»
«Mi sento male, ho i crampi»
«Buona che non sento niente, ehi scusi»
Tossicchio risalendo dalla vasca, e:
«Buonasera. Sono Manuele. Appena sceso».
«Cosa le hanno detto i gallu?», mi chiede una voce di donna.
«Niente».
«Le hanno lasciato tenere qualcosa?», insiste la voce.
«Solo il…»
(Zitto, Manuele, che te lo rubano.)
«…qualche libro. Ce li ho nello zaino. Per ammazzare il tempo».
«A me hanno lasciato la mia collezione di francobolli», piagnucola una voce in lontananza. «Vorrei vedere il lato positivo ma non ci riesco».
«Ma dai, Giampaolo, è pure completa», lo rimprovera una voce accanto a lui.
«Ho capito, ma i francobolli li guardi, non li palpi».
Educatamente, avanzo a tentoni, cercando di non ficcare le mani su tette, facce o culi. I miei fratelli e sorelle umani sono sparsi per questo grande costone di pietra, dove si diramano canali e piscine di acqua corrente. Si tengono vicini a gruppi, come vitellini senza la mucca, stretti stretti come mazzi di fiori. Passo di gruppo in gruppo, dico il mio nome, sento parlare dieci lingue diverse – non ci sono amici né parenti, i gallu ci hanno divisi, hanno spezzato le famiglie e separato chi si voleva bene. Io sono un uomo di affetti moderati, ma il dolore altrui lo sento eccome. Sta tutto nelle loro voci, nel tremolio lamentoso che sento spargersi per l’aria buia, nel respiro accelerato, nei mille groppi in gola mentre cercano di articolare un discorso senza scoppiare a piangere. Il bastone è rientrato nello zaino, non voglio che si senta il suo ticchettio esplorativo. Dopo non so quante ore, la situazione è sempre la stessa. E ricordo quello che leggevo da bambino sull’oltremondo di Sumer e Akkad, il Kur – erṣetum la târi, la terra del non ritornare – mātum šaplītum, il paese interiore. Non tanto un posto terribile, qui nessuno ci dà il tormento – ma un posto monotono, noioso, dove la gente rimane senza far nulla per il resto dell’eternità.
Sto abbracciando mio malgrado una bambina che mi ha scambiato per suo padre, quando qualcosa in lontananza attira la mia attenzione. Un’area della tenebra si è accesa. Distinguo vagamente una zona illuminata, e colonne nere sullo sfondo della luce bianca. Allo stesso tempo mi rendo conto che i gallu, credendomi completamente cieco, non mi hanno dovuto accecare attivamente – lasciandomi perciò questo piccolo superpotere di cui però mi conviene non dire niente, ché qui sennò mi mangiano vivo (e si prendono il bastone). Arranco a tentoni verso quelle masse nere che vedo sullo sfondo della luce. Quando sono a pochi metri, smetto di distinguerle e vedo solo la tenebra violetta – quasi ci vado a sbattere. Sono colonne di pietra, niente di strano. Ma facendo il giro mi accorgo che sono cave. E all’interno – gradini. Provo a risalirne uno. In capo a pochi minuti sono su una piattaforma stretta e lunga, dove per non rischiare mi muovo carponi. Finisco dentro un cunicolo che mi costringe a cambiare direzione più volte, finché non esco di nuovo all’aperto (per modo di dire). La luce di prima ora è sotto di me, ma ce n’è un’altra molto più in alto, ed ecco che la piattaforma diventa un costone di roccia. Non sto capendo la geografia di questo posto. Mentre continuo a non capirla, mi sbilancio e finisco di nuovo in acqua. C’è un’altra vasca, poco profonda e tiepida. Ci sguazzo finché non riemergo. La luce sopra di me si è fatta incandescente e questa caverna – sopra l’altra? Sotto? – contiene altri esseri umani. Sento le loro voci e sullo sfondo della luce mi pare pure di distinguere le loro ombre. Mi rimetto in piedi e sto per avvicinarli, quando una voce accanto a me mi fa fare il salto del gatto che si accorge di un ragno.
«Sei Manuele?»
Scivolo, batto il culo per terra.
«Manuele? Sei tu? Ho riconosciuto il respiro».
«Sono proprio io, Paolina».
(Una mia ex di tanti anni fa.)
«Dio cristo. Sono mesi che vagabondo. Sei la prima persona conosciuta che incontro».
«Ci hanno mischiati», confermo rimettendomi in piedi. D’istinto allungo la mano per capire dov’è, e –
«Chi c’è con te?»
«Non so come si chiami. Non parla. Me lo sono trovato quando sono scesa nel Kur. Era solo, mi ha seguita».
«Ma è… è un bambino?»
«Direi. Sette otto anni, penso».
«E te lo sei tirato dietro per tutto questo tempo?»
«Non se ne va. E mi impedisce di pensare a –»
(Ora che ci penso, Paolina dovrebbe avere una figlia dell’età di questo coso. Che chissà dov’è ora, però.)
«Manuele, bella merda essere ciechi, comunque».
«Dillo a me».
«Ma tu ci sei dentro da una vita. Io da boh, due mesi. È un inferno».
«Eh, se ci diventi da adulto…»
«Sento dalla voce che stai molto meglio di me. Hai il tuo bastone? Farebbe comodo».
«Sì, ma non dirlo in giro. Ho paura che me lo rubino».
«Ci sta. Da quanto sei qui?»
«Poche ore. Mi hanno lasciato… credo in un livello inferiore, sotto a questo. O forse… ma non saprei».
«Questo posto non ha senso».
«Ma senti, in due mesi avrai mangiato, o bevuto…?»
«Non ho più né fame né sete. Nessuno di noi ce l’ha».
«Come essere morti».
«E quello siamo».
«Io mi sento vivo, Paolina».
«Questione di punti di vista».
Segue una pausa piena di disagio.
«Dove stai andando?», chiede Paolina.
«Verso la luce», rispondo senza pensarci. «Mi dà un’idea di com’è fatto l’ambiente. Ma da quello che capisco, qui non è molto diverso da…»
Manuele, cazzo di lingua lunga…
«La luce», gracchia Paolina. «Tu riesci a…»
La sento schioccare le dita.
«Ma certo. Tu non sei completamente cieco, giusto?»
«Paolina, parla piano…»
«Scusa. Però è così, no? Mi ricordo che…»
Manovrando la mano a caso, le trovo il polso e lo stringo.
«Sono diventato cieco a sei anni. Praticamente è come esserlo dalla nascita. Cosa vuoi che mi ricordi? E comunque non ci ho mai visto bene nemmeno prima, ho una malformazione congenita al nervo ottico. Semplicemente a sei anni il danno si è aggravato. L’unica cosa che riesco a distinguere, se sono abbastanza forti, sono i contrasti. Molta luce su molto buio. Oggetti solidi in controluce. Tutto qua».
Paolina ridacchia:
«Ti ho portato al mare a Ferragosto, alla Grotta della Poesia. C’era pochissima luce in giro e tu riuscivi a vedere la luna piena. Che ricordo mi hai sbloccato».
«Non la vedevo. Mi pareva di vedere un disco bianco, una specie di macchia, su fondo nero. Basta. All’atto pratico non sono molto diverso da qualunque altro cieco».
«Però questa capacità ce l’hai ancora, no?»
Grugnisco.
«Così pare».
«Butta via».
«Paolina, se lo dici in giro io sono fottuto».
«Ai gallu lo hai fatto presente? No, scusa, che stronzata, ti avrebbero accecato completamente. Ora che ci penso, sono convinta che poco fa ce ne fosse uno nei paraggi. Sentivo i suoi artigli sulla pietra. Camminava in mezzo ai gruppi di umani, senza fretta…»
«Paolina, cristo santo».
«E datti una calmata. Non vado a sputtanarti».
Silenzio.
«Però mi devi dare una mano».
«Aha? E come?»
«Portami con te. Io e Samuele, qui».
«Hai detto che non parla. Come fai a sapere…»
«Non lo so. L’ho appena ribattezzato. Senti, hai un bastone con te e vedi i contrasti. Non penso ce ne siano molti altri come te in giro. Sei un re, Manuele».
«Non dire idiozie».
«No? E il proverbio? Beati gli orbi nella terra dei ciechi…»
«Sono praticamente cieco».
«Sei un pochino meno cieco di me. O di Samuele. A noi basta questo».
Mi sfugge un sospiro irritato.
«Non credo ci sia molta gente nelle vicinanze», riprende a dire Paolina.
Mi guardo intorno. Non distinguo alcuna forma. Ma il rumore dell’acqua corrente intorno non basta a bloccare quello delle voci. E Paolina ha ragione, sono molto lontane. Tiro fuori dallo zaino il bastone e lo apro.
«Che è questo tlac-tlac?»
«Il bastone. Stai zitta e seguimi. Cercherò di non fare casino con la punta».
«Come ti seguo? Ti prendo la mano?»
«La spalla».
«Dove stiamo andando, Manuele?»
Muovo il bastone sul pavimento intorno a me. Ecco il bordo di un’altra piscina – da qui non capisco se è un canale o una vera e propria cisterna. L’acqua gorgoglia. Se andiamo avanti, ci lasciamo la luce a destra – ma lì ci sono sicuramente persone e invece in questa direzione, chissà.
«Manuele? Non mi hai detto dove vuoi andare».
«Non ne ho idea, Paolina. Come in qualunque posto dove sono stato nella mia vita, non ho la più pallida idea di come sia fatto prima di averlo percorso sessanta volte con mani, piedi e bastone. Non ho modo di scoprire dove sono a colpo d’occhio».
«Vabbè, nemmeno io. Nessuno di noi può».
«Ecco. Quindi quello che succede ora, è che noi tre andiamo a esplorare».
«Così, a caso?»
«Se non sai cosa stai cercando, una direzione vale l’altra».
Paolina non risponde.
«Capisco che per te la cosa sia traumatica», riprendo «ma credimi, e te lo dice un cieco, perché io sono cieco, anche se tu pensi di no: quello che per te è l’inferno, per me è l’ennesima regione da esplorare».
Paolina non risponde, ma sento la sua improvvisa tristezza.
«Un altro mondo da palpare, se preferisci. Quindi, se proprio ci tieni, seguimi in decoroso silenzio, tu e il coso qui. Che a me le chiacchiere non piacciono, come ricorderai».
Lo ricorda benissimo. Attraversiamo caverne gargantuesche, a volte dotate di queste fonti di luce piena, come soli sul soffitto di pietra, a volte percorse da questa lucina stagnante, imprecisa; una dopo l’altra guadiamo polle di acqua connesse da canali, in questo sistema idrografico sotterraneo dove le cascate vanno anche all’insù, se occorre. Di tanto in tanto le acque precipitano in abissi di cui ignoriamo la profondità; e ogni volta ci manca il coraggio di lanciarci per farla finita. Paolina evita i rumori superflui: sento il suo respiro, le sue mezze parole di rabbia quando inciampa o mette un piede in fallo, le paroline affettuose a Samuele quando punta i piedi e si rifiuta di andare avanti, di tanto in tanto le sue lacrime. Mi avvisa se pensa di sentire delle voci umane, per farmi nascondere il bastone; altrimenti, con me non parla. Prima o poi romperò il silenzio e le leggerò qualcosina dai miei libri – anche perché qui ci si annoia facile, una volta che capisci il meccanismo. Certo però che a leggere solo io, ad alta voce. Nei momenti morti potrei fare uno sforzo e provare a insegnarle il braille – tanto qui di tempo ne abbiamo.
A illustrare, una fotografia di Brent Moore.