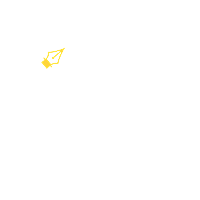Medusa
Click.
Come una porta che si spalanca per poi richiudersi dopo pochi istanti.
Click, tu tum, click, tu tum, click, tu tum.
Un incastro tra macchina e carne umana, quasi una melodia di fondo che mi rimbomba nei timpani. Il mio respiro accelerato s’insinua nel mezzo, scandendone il ritmo. L’eccitazione controllata, nient’altro che una pulsazione tra le cosce. E Jess davanti ai miei occhi, ignara della mia presenza.
So che non dovrei essere qui, me lo ripeto in continuazione nella mente, vai via, vai via, vai via, come una nenia, la preghiera di un rosario, ma so anche quanto mi faccia stare male non assecondarle.
Le mie visioni, intendo, le allucinazioni. Ho provato a dare la colpa agli acidi e all’assenzio, alla genetica e pure a Dio, ma la realtà è che non me ne frega un cazzo di sapere da dove vengono: voglio solo guardare attraverso l’obiettivo della mia macchina fotografica, lasciar fluire i pensieri, renderli liberi di plasmarsi da sé.
E quindi adesso sono qui, a spiarla, nascosto come un infame, e questa maledetta erba è così bagnata che non riesco a concentrarmi.
Non mi interessa. Voglio quella fotografia, quell’immagine che sto cercando, è tutto ciò che conta.
La prima volta che vidi Jess fu a una mia mostra: le pareti della galleria erano così bianche da ferirmi gli occhi, mentre i suoi capelli mi apparvero così rossi, così vividi, che quando entrò nella stanza fu come se mi fosse piombata addosso una colata di lava.
Diventò la mia ossessione.
Dovevo averla, possederla, dovevo catturare la sua essenza.
Mi si avvicinò persino, impertinente, chiedendomi perché facessi fotografie “di un certo tipo”, e mi chiese il permesso di farmi un appunto. Un appunto. A me, Ivar Norman. Le donne non mi fanno appunti, si lasciano scopare e, se ne ho voglia, scatto qualche fotografia. Ci stanno solo perché sono qualcuno nel giro, per infilarsi in questo mondo marcio, lurido, che è il successo e la fama.
Jess mi chiese perché disponessi sempre le mie modelle in posizioni di sottomissione, prone, in ginocchio, di spalle o a testa in giù. Temetti fosse una femminista contemporanea, ma ne venne fuori che la sua era una curiosità tecnica più che un rimprovero. Quando pronunciò la parola sottomissione, il mio cervello impazzì: la portai in bagno, la piegai sul lavandino e la penetrai senza cerimonie, una mano sulla bocca e l’altra incastrata tra quei capelli ustionanti, i suoi seni due stelle marine polpose e vibranti. Bollente e morbida, come seta appena stirata.
Mi ferii. Mi scottai. La sua voce cantava.
Ivar, Ivar, Ivar.
Sollevai la mano e constatai, con una certa soddisfazione, che aveva lasciato il suo marchio su di me.
Quando battei le palpebre, mi accorsi che ero ancora nella galleria, con Jess che aspettava che rispondessi alla sua domanda e la mia mano era liscia e immacolata come sempre. La sua voce mi riportò alla realtà, come l’eco di una sirena al contrario. Mi ripresi quel tanto che bastava per cancellare gli stralci della visione e provai a replicare, ma senza successo.
Lei sorrise. Io mi persi in un effetto louche: i miei pensieri si fecero confusi, lattiginosi, si aggrovigliarono tra loro.
Le sfilai il numero di telefono, la chiamai qualche giorno dopo e la invitai a casa mia. Rifiutò.
Provai con un invito a cena. Rifiutò anche quello.
Mi sentii morire, dovevo assolutamente rivederla, toccare i suoi capelli, succhiarle le labbra, contare tutte le lentiggini sul suo corpo, infilare le dita ovunque.
Dovevo fotografarla.
Aspettai qualche settimana, non volevo spaventarla. Fu lei a chiamare per chiedermi di incontrarla in un cafè nel West Village. Ne rimasi sorpreso. Non dissi quasi niente, la ascoltai parlare. Mi persi nei suoi occhi da mostro divino. La mia mente continuava a ripetere prendila, baciala, stringila, ma non era quello il momento giusto. Le feci un paio di fotografie però: nella prima, una testa di Medusa, due orbite completamente nere e un sibilo attraverso la lente. Un’immagine terribile, bellissima.
La vedevo per com’era davvero e chissà se lei lo sapeva.
La seconda mi mostrò il mio capo incassato nel suo collo, le dita sotto il lembo di una gonna, un respiro, due, un gemito, due, una richiesta fatta a bassa voce, il godimento accennato. Mi eccitai. Decisi che avrei dovuto incontrarla di nuovo. Non l’avrei sfiorata con un dito. Solo se avesse voluto anche lei. Solo così.
E quindi sono finito qui, sotto la finestra della sua camera da letto,
L’erba del suo giardino è bagnata, ma non fa niente.
Mi ricorda che non sto sognando.
Click, tu tum, click, tu tum, click, tu tum.
Jess non si è ancora fatta vedere. La sento canticchiare, la voce ovattata, pigra. Si trova in un’altra stanza, forse in bagno. Un movimento mi allerta, ma è solo il suo gatto grigio che mi guarda fisso. Si è accorto della mia presenza, allora sollevo la macchina fotografica e scatto un’altra foto, il rumore dell’otturatore che sembra un scoppio tanto il silenzio del quartiere è profondo.
Inspiro, devo fare piano.
Ed eccola finalmente.
Fiorisce una visione: la bottiglia di vino sul suo comodino sta cambiando forma, il vetro si scioglie e tutto evapora in una nuvola rossastra, volute arricciate che si appiccicano al soffitto. Scatto e quando controllo lo schermo vedo solamente una bottiglia di vino. E un seno, un accenno di seno.
I miei occhi ora sono solo per Jess che si sta spogliando, ma tutto ciò non ha nulla a che fare con la nudità, non è quello che mi serve. È come essere delle sabbie mobili: ho bisogno di catturare le immagini del mondo, di assorbirle lentamente. e più provano a muoversi, più io devo farle mie.
Ho bisogno di rubare l’indispensabile: l’intimità, la solitudine, l’anima.
Jess cammina per la stanza, indossa solo un asciugamano striminzito, le mani occupate ora da una camicia, ora un paio di jeans, ora degli autoreggenti. Sembra indecisa, infine sceglie i jeans e lancia le calze sul letto.
Io registro il movimento, ma ne modifico la sostanza.
Click, tu tum, click, tu tum, click, tu tum.
Seguo la loro forma, attirato da un lievissimo tremolio della stoffa: la mia mente li trasforma velocemente in un paio di serpenti neri, lucidi, frementi. Posso vederli, posso anche sentirli, vagamente viscidi, untuosi. Si precipitano giù dal letto, strisciano sul pavimento, una scia scura dietro di loro, e cominciano a risalire sulle gambe di Jess, uno si avvolge intorno alla sua caviglia destra, l’altro è già su una spalla, il sibilo della lingua tra i capelli.
Li trovo meravigliosi.
Scatto una foto. Jess incespica contro una scarpa, i serpenti spariscono. Lascia cadere l’asciugamano a terra e un flash improvviso, l’immagine candida di una statua antica, mi esplode nella testa. Il dolore è lancinante, mi fischiano le orecchie, sono costretto a piegarmi sulle ginocchia, aspettare che la visione si decomprima dalle mie sinapsi.
Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Un gemito. Sollevo lo sguardo, Jess è ancora nuda in giro per la stanza. So che non è giusto guardarla così, allora abbasso lo sguardo.
Inspiro, espiro. Inspiro, espiro.
Dopo un paio di minuti, la pressione sulle mie tempie sembra allentarsi. Lei nel frattempo si è infilata un completino intimo bianco. La sua schiena è punteggiata di lentiggini, ed eccola di nuovo la stessa visione di poco fa, una statua vivente che comincia a muoversi dopo secoli di stasi, le dita impacciate, nodose, un coltello alla gola, un movimento chirurgico e un fiotto di sangue caldo che schizza dappertutto, macchiandone la superficie perfetta, spargendosi in miliardi di punture rosse che si cementano sulla sua pelle.
Riesco a controllare la fitta alla testa, ma non quella tra le gambe. Devo assecondarla. Scatto una foto. Lei si gira all’improvviso verso di me.
Mi ha sentito?
La finestra è spalancata sul giardino, c’è silenzio. Stringo i denti e mi nascondo meglio cercando di non fare rumore. Per fortuna l’erba è bagnata.
Vai via, vai via, vai via.
Silenzio! Taci.
Il rame liquido dei capelli di Jess calamita la mia attenzione. Scatto ancora. Non riesco a prendermi quella cazzo di foto, la foto di cui ho bisogno.
Devo avvicinarmi un po’ di più.
Jess non mi ha sentito. Striscio sull’erba, la finestra è sempre più vicina. Il gatto grigio sibila e soffia. Maledetto, vorrei spezzargli il collo.
Lei ricomincia a canticchiare e a quel suono si aggiunge il rumore di un paio di tacchi. Sta per uscire, devo sbrigarmi, deve essere stasera, lo so, lo sento.
Mi sporgo troppo e i miei occhi incontrano quelli di Jess. La sorpresa è assoluta, ma solo per me, perché lei non urla, non dice niente, non sembra neanche spaventata. Mi sorride, anzi, come la prima volta alla mostra, le lentiggini sul viso che d’improvviso si raccolgono tutte insieme nelle sue fossette.
Vorrei baciarla fortissimo, assorbire il suo respiro, infilarle le mani nei capelli, farmi piccolo, minuscolo, ficcarmi sotto la sua pelle, come un virus, un microbo, e finalmente diventare parte di lei. Ma non mi permette di farlo.
Non dice niente, non sembra spaventata.
Vai via, vai via, vai via.
Zitto, non ora!
Lascio cadere la macchina fotografica, scavalco la finestra ed entro in camera. Jess mi prende per mano, mi porta verso il letto. Io faccio per abbracciarla, ma lei mi spinge via.
Perché non parla? Continua a sorridere però, dolce, dolcissima. Non resisto, sento i pantaloni sul punto di esplodere.
«Jess…?».
Lei mi mette un dito sulle labbra, mi spinge sul letto con violenza. Resto interdetto. Un’altra fitta lancinante mi taglia le tempie, la visione della vera Jess proprio davanti agli occhi, una Medusa nera e lucida e tremante, il capo percorso da miriadi di piccolissimi serpenti, gli occhi d’onice freddo.
Viene sopra di me in un attimo, mi sfila i pantaloni, lei si sfila i suoi.
Tu tum, tu tum, tu tum.
Sento solo il mio cuore sul punto di arrendersi. Non ho la macchina fotografica, non posso catturare niente. Jess si china su di me, mi morde il collo, i suoi serpenti mi sibilano in mezzo agli occhi.
«Baciami».
Silenzio!
Tu tum, tu tum, tu tum.
Un brivido mi scuote. Ho freddo, ma lei ribolle, è così calda che non ci faccio quasi caso. Eppure, in un angolo recondito della mente, sospetto che ci sia qualcosa di sbagliato. Jess non parla, lei che di solito non chiude mai la bocca. Non parla, mi succhia e io mi sento leggero, assorbito. Uno dei suoi serpenti s’infila tra i miei capelli. Un altro brivido, non è più così piacevole.
Mi ritrovo dentro di lei senza sapere come sia successo. Ma non me ne frega niente, adesso voglio solo scoparla.
Tu tum, tu tum, tu tum, tu tum, tu tum, tu tum.
Afferra d’improvviso la bottiglia di vino, prende un bel sorso, un po’ troppo forse, però poi me lo sputa subito in bocca e dondola dolcemente i suoi fianchi sui miei. Finalmente mi bacia, il vino caldo mi scorre addosso, nella gola, lo tracanno, sa di roccia e di terra, di carne viva, di lei. Ne voglio ancora.
Un altro serpente tra i capelli, poi uno nell’orecchio, un altro ancora nella narice.
Rabbrividisco e qualcosa nella testa mi dice di correre, ma non capisco dove e nemmeno perché, ora che Jess si muove più veloce. Le strattono i capelli, quei capelli aggrovigliati, gelidi, e lei mi concede altro vino, e ancora e ancora e ancora, fin quando la bottiglia si svuota.
Finalmente tutto tace: sparisce ogni sussurro, ogni suggerimento, ogni consiglio non richiesto. Avverto con chiarezza lo spazio dietro alle mie orbite, un deserto silenzioso. Mi sento quasi una persona normale.
Ivar.
La voce cavernosa di Jess mi richiama. Sorride e si china a baciarmi ancora, i suoi serpenti si avvinghiano alla mia faccia. Non respiro più, sento il sapore del ferro in bocca. Forse è sangue? Il mio o di Jess? Ma lei è così bella, spaventosa e splendida. Mi rendo conto di amarla. Di volerla, nonostante tutto. Le concedo tutto me stesso. Mi pietrifico nel suo orgasmo, immobile ormai per sempre.
Tu tum, tu tum, tu tum, tu tum, tu tum, tu tum.
Boccheggio, per l’affanno e il piacere.
Tu tum, tu tum, tu tum.
Non sento più le gambe né le braccia.
Tu tum.
Jess, nuovamente umana, si accarezza le punte dei capelli, compiaciuta. La scorgo solo attraverso la fessura dei miei occhi perché sento che sto per andare altrove. Vorrei tossire, ma il fiato mi muore nel petto. Ancora su di me, si china di lato e tira fuori da un cassetto una macchina fotografica gialla, una vecchia polaroid. Mi chiede di sorriderle, ma le mie labbra sono scivolate di lato, come se si fossero liquefatte. Mi scatta una foto mentre annaspo per gli ultimi respiri che mi restano.
Tu tum.
Jess si rialza dal letto. Sorride, buttandosi la chioma all’indietro. Prende gli slip, si pulisce, poi li ributta a terra. Il gatto corre ad annusare. Si avvicina a una parete in fondo alla stanza e con una puntina vi attacca la mia foto: non riconosco l’uomo che mi guarda, quell’Ivar Norman osannato da mezza città per il suo talento. Noto su quella parete altre decine di facce come la mia, uomini adulti, giovani, biondi, bruni, ma tutti con la stessa espressione di terrore pietrificato negli occhi. Io sono l’ultimo, quello che va a finire in fondo alla sua collezione.
Adesso c’è buio e silenzio.
Faccio in tempo a lanciare un’ultima occhiata alla bottiglia di vino mortale.
Mentre tutto si offusca, mi rendo conto di come lei abbia fatto di me un oggetto inutile, risucchiandomi dentro le sue sabbie mobili.
Mi sento felice.
Ora abbiamo entrambi la foto di cui avevamo bisogno.
A illustrare il racconto, un particolare del Fregio di Beethoven di Gustav Klimt.
Del tuo veleno mi avvelenerò.“