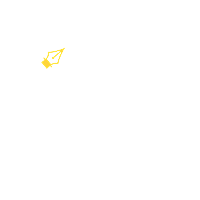Spaghetti alla Carbonara pt.2
Conosco la verità. Non siamo rimasti in molti a conoscerla, quasi tutti decrepiti, senza progenie o mal sopportati dai nipoti. La campana deve pur suonare per qualcuno. Questo rintocco è per me. Al termine di queste pagine sarò uno straniero in casa mia, un paria, rinnegato, e anche un bugiardo. Al mio paese non è mai interessato granché il mio sostentamento, e non ricordo d’aver mai bevuto latte dai suoi capezzoli. Ero io a nutrire la bandiera. Non è molto, ma è l’unica storia che posso raccontare.
*
Il salvagente mi tenne a galla. Persi conoscenza poco dopo essere riemerso. Quando arrivai a Napoli avevo la polmonite, torturato da pulpite e da un’encefalite intermittente, con tre dita del piede destro in meno.
In marina sempre zuppa, e in nosocomio minestrine color grigiastro, con pochi, smunti e inermi piselli che galleggiavano in superficie, o croste di pane annegate sul fondo. Sul Lubiana, il cacciatorpediniere, la mia mansione era portare i pasti quanto più vicini alla soglia della commestibilità. Io dovevo solo far da mangiare, riempire prima i pentoloni, i piatti, e, alla fine, gli stomaci. Poi, raschiare via le incrostazioni di sebo carbonizzato dal fondo dei pentoloni. Almeno, al Complesso degli Incurabili, avevo qualche genere di conforto: la morfina australiana era tutta un’altra storia rispetto all’acquerello che davano a noi, e assaggiai le Razioni C degli americani. Erano già state dismesse in favore delle più moderne e nutrienti razioni K, ma noi ci avventavamo sopra quelle lattine come fosse una cascata di latte condensato. Tre once di brodo di carne in polvere, frumento bollito, tre barrette di cioccolato dolce, sale, pepe, quattro sigarette Old Gold, e tre biscotti. Il carnaio di bende sudice, topi e pelle non lo rendeva il posto peggiore che avessi mai visto. Per due mesi, la polizia militare italo-inglese ci segregò in una camerata di centoventi metri insieme a una ventina di feriti che invocavano la mamma, bestemmiavano e si smaneggiavano sotto le coperte. Da qualche parte nell’ospedale si stava diffondendo un’epidemia di difterite.
Non appena aprirono le porte dovetti trovarmi qualcosa da fare. Non vedevo l’ora di scoprire in che fogna preparassero la brodaglia con cui tentavano di ridurre il sovraffollamento. In cucina non c’era neppure la speranza per piangere. Mi ci volle una settimana per sgrassare il mantello di sporcizia che la rivestiva, con l’aiuto di una brigata di orfani che mi frugava nelle tasche ogni giorno. Per prima cosa feci il pane. Pane di segale, frumento, mescolata con farina di noci e castagne, e dei panini all’olio e rosmarino, che feci portare ancora caldi all’alloggio del maggiore Peterson in via Donnaregina. Venne a trovarmi in ospedale il giorno dopo, forse due, e fu entusiasta di accordarmi i fondi per comprare merce alla borsa clandestina. Disse che mi avrebbe mandato i migliori cuochi della Fifth Army North sopravvissuti ad Anzio. Il cambio dell’Am-Lira-Dollaro era cento a uno, l’inflazione lievitava e i contrabbandieri presero a preferirle il baratto. Mi diedero anche settanta dollari e assegnò a quei fondi una scorta armata di due uomini. Non un edificio di via Colombo era rimasto in piedi, se non per un tramezzo, o il profilo di una porta. Il mercato si teneva nella vecchia chiesa personale di una famiglia principesca. Non era ancora formalmente sconsacrata, ma lo sarebbe stata presto. Ci vollero sei ore per recuperare le due forme di parmigiano e le scatole di spezie di provenienza turca che ordinai. Risalivano a una razzia di vent’anni prima, ma le latte parevano ben sigillate. Comprai anche due damigiane di Falanghina annacquata, dieci chili di cacio, due chili di sale e cinque pacchetti di sigarette tedesche.
Cucinai fino a notte fonda. L’ospedale mobilitò dieci infermiere solo per tirare la pasta. Alle quattro avevo finito tutto il cacio e gran parte del pepe, e distribuito porzioni per sfamare una divisione. La voce si sparse in fretta, la mensa dell’ospedale spalancò le porte a tutti gli affamati con in tasca il minimo indispensabile per sfamarsi. Alle quattro del mattino ero fradicio di poscia e sudore. Il maggiore Peterson si presentò di persona. Il giorno dopo, il suo attendente venne a svegliarmi insieme a un carabiniere. Avrei dovuto cucinare di nuovo per la sera. Avevo a disposizione cinquanta chili di pancetta, poco più di un quintale di uova sbattute in scatola e poco meno d’ottanta chili di albume in polvere. Non avevo idea di che oscenità sarebbe venuta fuori, e manco me ne preoccupavo. Non avevo mai avvelenato nessuno, non abbastanza da fargli temere per la propria vita, e mai per mie specifiche negligenze. La cucina era sempre servita a risparmiarmi i proiettili. Aveva funzionato bene. Avevo già versato alla guerra la mia quota d’invalidità, e lei era in procinto di liquidare la mia pensione.
Lo stesso attendente tornò anche il giorno dopo. Mi avrebbero dato tutto il bacon e tutte le uova in scatola che mi servivano, a patto che continuassi a preparare la stessa pasta per tutta la settimana. Mi andava bene, ma avevo bisogno di altro pepe. E magari del pecorino.
Arrivai a Roma con la seconda ondata di liberatori. Il locale in cui mi alloggiarono era piccolo e malconcio, con una bella cantina che qualcuno aveva già ripulito. Stipai i fiaschi di nero d’avola ed Etna rosso portate dalla Sicilia, impilai le latte con uova e la pancetta in scatola e presi alloggio in una stanzetta affacciata sulla corte interna del vicolo dei Cenci. Entro sera sarei dovuto partire, al personale pensarono gli uomini del maggiore. Non facemmo grandi pulizie, non ne avevamo bisogno, del resto ancora si sparava e a lungo si sarebbe ancora combattuto per arrivare alla pace. Se l’Italia era in guerra, anche le sue cucine dovevano considerarsi parte belligerante. E io ero uno dei suoi tanti cucinieri. Qualcuno, molto tempo dopo, inciampato chissà come in questa storia, provò a chiamarmi chef. Non sono mai stato francese, né ho mai visto il cibo come qualcosa di diverso da materia compostabile. Ero già vecchio quando consumai il primo pasto per puro piacere, infatti non mi ci sono mai abituato. Verso novembre La Sozza chiuse per la prima volta. Il nome lo trovai sull’insegna e non ebbi cuore di cambiarlo. Erano gli Alleati a metterci la materia prima, in cambio dei due terzi della moneta che entrava in cassa. Riaprimmo poco prima di Natale. I coperti aumentarono ancora quando riuscii a mettere le mani sulle prime forme di pecorino, parmigiano stagionato e salsicce piccanti. Nell’inverno del quarantacinque, a Roma, la vita sembrava aver imparato a recitare una credibile condizione di normalità, all’unica offerta della Sozza s’aggiunsero due primi, due secondi e un antipasto misto.
La guerra finì, i soldati rimasero, ma i quattrini ripresero a girare. Pagai una squadra di muratori per abbattere un muro, tinteggiare e rifare l’impianto elettrico. Non mi accorsi della concorrenza finché vidi ridursi i coperti. Fu non molto dopo le elezioni. Una coppia di anziani ricconi rovesciò i piatti per terra e se ne andò senza pagare, bofonchiando di un posto a San Lorenzo al quale avevo rubato il cavallo di battaglia per vomitarci merda sopra. Feci delle ispezioni nei ristoranti vicini, ma nessuno riproduceva il mio piatto, così andai a San Lorenzo e feci lo stesso per tutte le osterie tra la Basilica, Porta Tiburtina e l’Esquilino. Non l’avrei mai trovato se non fossi stato investito da una così familiare e, al contempo, estranea zaffata di profumo. Risaliva serpeggiante da un piattone adagiato su una tovaglia a losanghe. Entrai e ordinai. La chiamavano carbonara. Avevo letto altre volte quel nome scritto sulle lavagnette. Un boccone fu sufficiente a sciogliere tutta l’acrimonia che nutrivo per i due signori che mi avevano sporcato il pavimento.
Niente pancetta, ma guanciale, niente bianco d’uovo, solo rosso. Il pepe era rimasto, però.
Il cuoco era giovane. Raccontò d’averlo copiato da un tale di Piazza di Spagna, mi feci dire il nome e ci andai. Questo era vecchio, quindi depositario di incrollabili certezze e somme conoscenze sulla vita e gli alimenti. Sostenne che esisteva da sempre, lo chiamavano “il piatto dei carbonai”, che la consumavano durante le lunghe ore di monitoraggio della carbonaia. Proseguii la mia indagine con scrupolo. Decisi che l’avrei ordinata in ogni posto che l’avesse servita. Dopo due mesi non riuscivo più a trattenerla nello stomaco fino all’angolo. Tutti avevano cominciato a prepararlo dopo l’inverno del quarantacinque. Qualcun altro lo indicò come “il piatto dei carbonari”, quegli altri. Col tempo, ho cominciato a sospettare di essere arrivato per caso e necessità dove qualcun altro era approdato per genio. Scoprii che era avvenuto lo stesso per i fiammiferi. Mescolando alcuni elementi con un bastoncino, un farmacista vide che la sostanza sulla testa s’era seccata, e quando provò a grattarla via la testa, s’incendio come polvere nera. Li battezzò lampi di attrito, ma l’epiteto non fece presa. Fu così anche per le patatine fritte: un cuoco americano riceveva continue lamentele per le sue patate, troppo cotte fuori e troppo crude all’interno. Decise di tagliarle più sottili possibile e di cospargerle con una quantità di sale che egli giudicava insopportabile. In poche settimane, le sue french fries cosparse di sale divennero il piatto forte della casa, in un anno l’unica offerta del ristorante. E il cuoco non cucinò più niente di diverso per tutta la vita.
Il problema delle storie è che non sarebbero storie se ne esistesse una sola versione. Forse, è il loro pregio.
Quando altri la racconteranno, non ci somiglierà nemmeno.
*
Per la ricetta descritta dal nostro maéstro-professor Giulio Lepri, vai qui.