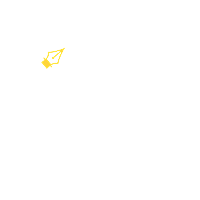Altre umanità
Da dieci anni il suo principale paziente era Diana, esemplare femmina di automa che aveva dato vita a ben dodici bambini. Famiglie altolocate finanziavano il progetto per poter affittare la cavità più fertile e promettente della storia.
L’azienda che si era occupata della sua fabbricazione aveva impiegato anni per generare un involucro straordinario, dove sviluppare feti che godessero di ottima salute e facoltà fuori dalla norma. Già dal quarto parto, però, il suo ventre si era trasformato in un panorama di avvallamenti frastagliati.
Seduta sul lettino della dottoressa Petroni, Diana ripercorreva con il dito le linee di pelle grinzosa ricongiunte in solchi e lembi sconnessi, che contenevano l’essenza più spessa dei suoi ricordi: memorie scandite da aborti e parti ma prive di qualsiasi esperienza sessuale.
La corsa alla vita coinvolgeva ogni potenza europea e in tempi record la Norvegia aveva assemblato un automa maschio, pronto ad approcciarsi a Diana e tentare la via della procreazione androide.
«Sapresti descrivere cosa hai sentito quando ti ha sfiorata?»
«Come prendere la scossa,» rispose Diana.
Il suono della sua voce era caldo e armonioso, ma qualcosa nel ritmo in cui articolava le parole depistava l’ascoltatore, come se parlasse leggermente accelerata.
L’androide maschio aveva collezionato pochissimi ricordi e, come Diana, era vergine. La sua creazione risaliva a qualche mese prima e da allora aveva visitato solo due luoghi: la stanza sterilizzata dove passava le giornate a fare terapia muscolare e la cella dai vetri oscurati dove si erano incontrati.
Gli esercizi che svolgeva ogni giorno per apprendere e abituarsi ai movimenti basilari non avevano ancora portato grandi risultati. Diana stessa se n’era accorta: a volte si muoveva a scatti; altre lento, come se le sue articolazioni fossero fatte di pietre. Gli occhi tondi e simmetrici e d’un celeste così chiaro da disturbare, poi, erano in ritardo rispetto agli spostamenti del busto.
Oltre i vetri oscurati, una squadra di dottori era intenta a trascrivere ogni loro reazione. Se l’androide maschio aveva dimostrato un atteggiamento dettato da curiosità e istinto, dovuto secondo la dottoressa alla sua più limitata esperienza di vita, Diana sembrava attratta ma restia. Era rimasta in piedi al centro, le cosce chiuse, come avrebbe fatto qualunque donna refrattaria a mostrarsi. Con le mani si copriva le cicatrici. Lui era passato subito al contatto, toccando con il palmo una landa sopra le costole, sotto il seno; e portandosi la mano libera tra le gambe: doveva essere la prima volta che il suo corpo reagiva in quel modo. Oltre i vetri, la sala scoppiò in un gaudio sommesso.
La dottoressa Petroni era l’unica a non esprimere entusiasmo. Osservava la sua paziente, ancora immobile, che aveva prediletto il contatto visivo, si era lasciata toccare ma non aveva toccato. Mentre il palmo di lui le circondava il fianco, la dottoressa registrò una serie di impulsi discordi dove, tra eccitamento e attrazione, la paura aveva accelerato smisuratamente il cuore.
Fece fermare l’esperimento.
Eppure, Diana affermò decisa alla dottoressa di volerlo rivedere.
Quando rimase sola, Silvia Petroni si stese sul lettino ancora caldo dov’era sdraiata la paziente. Era pensierosa: gli affittuari dell’utero, che pagavano il suo stipendio da psichiatra robotica, erano gelosi di quella creatura perfetta. Se l’esperimento con l’automa norvegese avesse portato davvero alla creazione della vita da geni androidi, sarebbe stato un passo inimmaginabile per la scienza. Se invece l’apparato riproduttivo così unico di Diana fosse rimasto danneggiato, le conseguenze per la sua carriera sarebbero state catastrofiche.
Si recò nella stanza adiacente allo studio. Una cucinetta con un tavolino neutro e un letto singolo era tutta la sua abitazione. Un’ampia finestra si apriva su un panorama nebbioso, una distesa desolata dove svettava un solo imponente edificio. Ogni piano era occupato da un unico appartamento. Ce n’erano dodici venduti e ventitré da rinnovare: erano gli appartamenti degli affittuari che – almeno una volta all’anno – portavano i figli generati da Diana ai controlli.
Tutti e dodici avevano le luci spente.
Il giorno successivo richiese un incontro individuale con l’androide: prima di assecondare un nuovo esperimento voleva indagare il suo stato di evoluzione e la sua eventuale pericolosità.
La stanza dov’era rinchiuso rassomigliava a una piccola palestra privata. Addossata lungo una parete c’era una serie di attrezzature per l’allenamento e lo sviluppo muscolare. Biciclette, nastri, pesi, pali, tubi metallici, strani itinerari da parkour si dipanavano sulla superficie del pavimento e sul soffitto, aggrovigliandosi nell’aria.
Nell’angolo a sinistra c’erano un letto e una piccola cucina identici a quelli della stanza di Silvia. Non c’erano tavoli né finestre.
Lo trovò appeso a una costruzione di corde a mezz’aria, dove si issava per poi spostarsi da una all’altra. La salutò con un cenno del capo, con disciplina terminò l’esercizio e si calò giù dall’ultima fune. Si sedette composto su una panca per pesi e per tutta la durata della seduta non lo vide mai sbattere le palpebre.
A differenza di Diana, parlava con cadenza rallentata. Era stato fabbricato con un corpo perfetto ed equilibrato, la postura dritta, i tratti scolpiti come un dio nordico. Era però ancora molto rigido, a momenti impedito. Per qualche millesimo di secondo un occhio non seguiva l’altro, dando una leggera impressione di strabismo.
«Potresti descrivermi la tua routine giornaliera?»
«Sì dottoressa. Mi sveglio, mi vesto, mi esercito. Faccio visite, mi esercito, tutto il giorno tutti i giorni. Mi svesto, vado a letto.»
Una sorta di eco metallica si udiva distinta in chiusura di ogni frase.
«Riesci a dormire bene?»
«Sì dottoressa. Il primo mese non ho dormito mai. Poi sono migliorato. Adesso la qualità del mio riposo è ottima.»
«E, dimmi, hai detto di vestirti ogni mattina e svertirti ogni sera. Significa che dormi nudo?»
«Sì dottoressa.»
«Ti è mai capitato di esplorare il tuo corpo nel letto?»
«No dottoressa, mi addormento sempre subito.»
«In altri momenti del giorno, invece, lo hai fatto?»
«Sì. Monitoro tutti i giorni i movimenti, la crescita muscolare. Quando faccio esercizi. Poi alle visite. Mi esercito e faccio visite tutto il giorno tutti i giorni.»
La dottoressa Petroni scosse la testa. «Dimmi, cos’è per te una donna?»
«Una donna è Diana» rispose.
«E cosa ti aspetti da lei?» chiese, poi si corresse: «Cosa ti piacerebbe… cosa pensi quando la vedi?»
Se fino a quel momento le risposte dell’automa erano state sistematiche e repentine, seppur articolate con lentezza, stavolta parve confuso.
«Non lo so. Allenarsi insieme?»
La dottoressa guardò gli attrezzi più vicini: intorno a pesi e bilance una catena spessa s’arrampicava nell’aria verso l’alto. Sul palo orizzontale da dove pendeva, le sembrò di indovinare le impronte dei palmi grandi dell’androide.
«Anche io sono una donna. Te n’eri reso conto?»
Lui spostò lo sguardo sul suo collo e poi ai seni e più sotto dove aveva toccato Diana, fino ai fianchi nascosti sotto al camice. Quando tornò a guardarla in volto l’occhio destro arrivò poco dopo.
La dottoressa si tastò un polso. Dentro alla manica teneva un piccolo elettrizzatore d’emergenza. Poggiò gli appunti a terra.
«Hai avuto voglia di toccare Diana quando l’hai vista?» Lasciò scivolare le mani sull’apertura del camice e si sbottonò fino alla vita. «Hai avuto voglia di toccare una donna?»
Avvicinò la sedia alla panca dov’era seduto e gli prese una mano: era gelata. La condusse fino al suo petto, gli aprì la via sollevando la coppa del reggiseno e gliela lasciò poggiare. Il contatto con la sua mano fredda la fece sussultare, e quei secondi che lasciò a lui per orientarsi con le sensazioni nuove servirono a lei per contenersi. Il palmo dell’androide si era scaldato all’istante e l’escursione termica le era risultata piacevole.
«Vorresti toccare così Diana?»
Non le rispose. Non si muoveva, ma la fissava con più intensità. Oltre la trasparenza di quegli occhi chiari Silvia riconosceva i chip di scansione.
Lasciò la sua mano sul seno e portò le sue sulle cosce di lui: cominciò a massaggiarle lentamente, avvicinandosi al bordo della tuta che gli cingeva la vita, fino a infilargli una mano tra le gambe.
Non c’erano peli. Sarebbero cresciuti nei mesi successivi.
Lui reagì all’istante: un’onda di calore si propagò dal centro del busto fino agli arti, infuocando di nuovo la mano ancora poggiata sul seno della dottoressa. Silvia ignorò qualsiasi impulso a cui il corpo la richiamava: cercando di concentrarsi sugli affittuari, sulla carriera, sui dottori che popolavano la stanza oltre i vetri oscurati, prese ad accarezzarlo tra le gambe sempre più veloce. L’androide adesso aveva l’aria spaurita, gli occhi vagavano tra le composizioni di tubi metallici e corde e catene che penzolavano in aria. Preso da spasimi e boccheggi, pareva indeciso se fermarla o lasciarsi andare; ma non ebbe tempo: esplose in un singulto che lo scaraventò con forza in avanti, la fronte contro la spalla della dottoressa.
Lei ritirò subito il braccio e se lo scostò di dosso.
Prese gli appunti con la mano pulita e si diresse verso la porta, lasciandolo in preda al suo corpo ancora ansimante.
«Dove vai?» le chiese, con sguardo disorientato e supplicante. Ma Silvia sparì dietro la porta.
La dottoressa si chiuse nel suo studio e si guardò la mano per un po’ prima di lavarla.
Nell’edificio di fronte si era accesa una luce. Adesso, solo un appartamento era abitato: una coppia conversava alla finestra, di spalle a uno schermo acceso, lo sguardo rivolto verso l’ospedale. Solo quando una delle due figure si recò nella stanza attigua Silvia riconobbe i profili di due donne.
Se c’era un bambino, era ancora troppo piccolo per poterlo scorgere oltre l’altezza delle finestre.
«Sono bella?» le aveva chiesto Diana prima di entrare nella stanza dai vetri oscurati. Era in tensione, fibrillava.
Quando l’androide norvegese entrò nella cella, fu lei a spingere per prima la punta del piede in avanti.
Stavolta, lui parve esitare. Le fissò il seno da lontano, poi avanzò meccanico, con gli occhi percorse il braccio che si stendeva di fianco, fino ad arrivare alla mano; la prese, come aveva fatto la dottoressa con lui, e se la portò sopra il membro.
Diana emise un grido e si liberò dalla stretta.
La dottoressa fece scattare l’allarme, la porta si aprì e due infermieri entrarono per far uscire la sua paziente. Sulla porta apparve anche Silvia e Diana si rese conto dello sguardo che l’androide rivolse alla dottoressa.
Il palazzo degli appartamenti era di nuovo vuoto. Le vetrate scure; i bambini assenti.
Diana tastava le cicatrici sul ventre, distesa sul lettino.
«Credi che potrebbe aiutarti conoscerlo meglio? Provare a stabilire un dialogo?»
Diana era seria e, per la prima volta, non la guardava. Gli occhi sbarrati erano rivolti all’edificio vuoto.
«In che modo, dottoressa?»
«Ad esempio con un incontro, una passeggiata, all’esterno?»
Diana si alzò di scatto, senza cambiare la direzione del suo sguardo, che continuava a esser puntato oltre Silvia, verso il palazzo dove alloggiavano i suoi bambini.
«Non mi ha guardato come la prima volta.»
Adesso, la sua voce era controllata e nell’incedere c’era una costanza anomala: «All’inizio ho pensato che fosse per le mie cicatrici» prese a ripercorrerle. «Ci ho pensato di notte. Non ho dormito» Voltò la testa – solo la testa, in maniera disumana, facendola ruotare sul collo – verso la porta dello studio. «È te che vuole?»
Girò su sé stessa, raddrizzando il corpo nella stessa direzione della testa. S’incamminò verso la porta.
«Diana. Aspetta. Dove stai andando?»
Ma Diana non uscì.
Chiuse la porta girando la chiave e l’estrasse.
Poi puntò la testa verso l’alto con uno scatto meccanico.
Spalancò la bocca, parallela al soffitto, e fece scivolare la chiave al suo interno.
Foto di Brayden Law