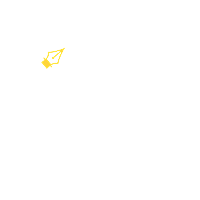Falene – Decreto Legge 023
La mia mano nella sua è calda e sicura come una bestia nella tana, anche se il cielo grava sulle nostre teste quasi fosse di materia solida e densa. Lei osserva il lento sgocciolare della grondaia, ora che il temporale è finito e la notte è cominciata. Non ci hanno ancora trovati. È questione di tempo, penso, mentre mi passo la mano sul mento, solleticando la barba. Il temporale fuori stagione, in questo inizio giugno, ha rasserenato l’aria. Restiamo stretti sotto la tettoia di lamiera della capannetta che ci offre momentaneo rifugio, illuminati dall’unica lampadina.
I cani squarciano il silenzio della notte con tutto il fiato delle loro gole. Letidia si fa più vicina a me, indica un bagliore lontano. La giacca è un po’ più piccola di quello che dovrebbe, e la manica le scopre il polso e i segni che porta addosso. Una serie di linee che attraversano la pelle e si accavallano.
Sembrano onde, piccole scosse telluriche, la preparazione a matita di una veduta contadina del ‘400. La mia mente si arrampica su una serie di suggestioni che mi mantengono vigile perché la notte ha un fondo che non riesco a vedere. L’immaginazione però, alle volte, non teme briglie e va dove vuole. Mi trovo a figurarmi l’espressione scura di Letidia mentre con il pezzo di specchio incide la sua stessa carne. Vedo i suoi occhi, ora così viola e così vivi, appannarsi lentamente, mentre il corpo che si rilassa e non sostiene più i brividi, scivola intorpidito nella vasca. Di riflesso la mia mano libera si chiude a pugno. I miei segni non si vedono, ma nell’ombra addolcita delle prime ore della notte, una ferita grande come il mio stesso corpo pulsa a un ritmo che non si accorda con quello del cuore.
Una falena si accanisce contro la lampadina all’angolo della tettoia. Ripenso alle circostanze della nostra fuga e mi pare di aver vissuto una scena d’azione di quei film americani, tanto idioti quanto assurdi. Eppure tutto è andato per il meglio, al punto che fatico a credere agli incastri fortuiti che ci hanno permesso di scavalcare la recinzione, di eludere le guardie, di correre all’impazzata nonostante la pioggia, la notte, lo sfinimento, la paura più cruda. Temo la beffa.
Ma di essere braccati, pronti al giudizio, anche a questo non ci si crede. Solo adesso, nonostante i mesi passati come in un sogno torbido, capisco che la mia colpa è concreta, che il giudizio è inevitabile e che la mia fine è sicura. Il decreto legge 023 è una di quelle cose della vita a cui non pensi finché non ci sei dentro, come una malattia. Che uno possa essere condannato a morte, dopo aver provato a morire per conto suo, è un paradosso non da poco. Se non fossi sicuro della totale mancanza di umorismo della Legge, ci troverei anche da ridere. Eppure è così, perché così è scritto: il dono della vita è qualcosa di talmente enorme che non lo puoi possedere in alcun modo.
Il tempo è un gioco al massacro. Alcuni non lo capiscono mai. Alcuni lo capiscono e fanno finta di niente. Altri, invece, lo capiscono e decidono di non voler giocare più.
Io lo capii che era febbraio, sui gradini fuori casa mia.
Dopo due anni che non la vedo, che non la vedo davvero, se si escludono le fatali coincidenze della grande città, Dora Martini mi invita a bere qualcosa per riallacciare i rapporti. Poche ore dopo, la osservo poggiare le labbra su un bicchiere, mentre parliamo del più e del meno. O meglio, sono io che parlo, che domando e incalzo, che cerco di decifrare quel mistero umano che ho di fronte. Nel momento in cui la mia lingua riceve un timido sorso di rosso un po’ acido, che fino a ora ho scaldato tra le mani, mi chiedo le ragioni per cui Dora è qui, davanti a me, dopo così tanto tempo, pronta a scardinare ogni previsione.
Va da sé che le ho pensate tutte. Ho costruito un teatro mentale, in cui noi due ci esibiamo in una danza calibrata di parole giuste e silenzi emozionanti, solo per arrivare al gran finale dei nostri corpi stretti e caldi. Dopo tutto questo tempo. E non che non mi fossi preparato, predisposto al meglio. Tutto questo tempo e io che la amo ancora. E adesso eccola, Dora Martini è qui, come un desiderio incarnatosi.
«Com’era quella poesia? “In un giorno ventoso, una luna sbeccata da un lato…”» chiede mentre i suoi occhi si schiudono.
Mai in tanti anni se n’era ricordata, e adesso eccola ritirare fuori Salomon Nocuìt, di cui le lessi al chiuso di un abitacolo, nella desolazione pomeridiana del parcheggio semivuoto di un centro commerciale, gli struggenti ultimi versi che il poeta scrisse prima di spararsi al cuore.
Capisco che è un segno. Lei di me, intendo di quello che ora sono e penso, non domanda niente. Non vuole sapere, non parla, non chiede e sono io che devo scoprire il fianco, per sentire sulla mia pelle quanto è aspra la ferita del mettersi a nudo. Ma il suo mistero è di pietra scura e il gioco finisce presto, quando Dora mi spiega le difficoltà dei preparativi del suo imminente matrimonio. Deve essere stato in quel momento che il tempo si è sfilacciato, come se la catena degli istanti si fosse slabbrata e i minuti colati su di me come cera fusa.
Ed eccomi definitivamente escluso dall’umanità intera. Licenziato dalla specie.
Spesso il dolore è un nome collettivo: nasconde una serie più o meno indefinita di piccolissimi dolori senza nome. I miei si erano fatti spazio nella profondità del mio stare al mondo che ogni cosa mi faceva male. Se le circostanze in cui affondavo i miei giorni fossero state diverse, allora… se non avessi vissuto nel nome di una frustrazione sempre più viva e sempre più feroce, sarei stato felice per Dora. Ma quello era un chiodo che chiudeva una bara, era una spinta che mi allontanava ancora di più dal mondo degli uomini. La felicità degli altri è uno specchio crudele.
Mi ricordo il momento, come se l’avessi visto mille volte al cinema.
Sto seduto sui gradini della scala, fuori dalla mia porta, due giorni dopo il nostro incontro. Non penso a niente, non vedo niente, solo un fragore che mi distrae da ogni cosa. Poi tutto d’un tratto un vuoto pneumatico nella mente, non sento altro se non come il rumore che fa una stanza senza mobili. E dura un’infinità, in cui accarezzo la sensazione di essere quel vuoto per sempre. Per la prima volta tutto mi sembra chiaro, capisco di aver deciso.
Mi alzo in piedi per quella che credo possa essere l’ultima volta, passo davanti allo specchio e vedo un residuo. Devo liberare un posto nel mondo, che occupo senza motivo alcuno. Devo riconsegnare queste energie in disuso. Il tonfo sordo del mio corpo, che cade di spalle dal quarto piano dell’anonimo condominio in cui abito, sconvolge un primo pomeriggio di un lunedì qualunque, nel quartiere di periferia di una città che è tutte le città.