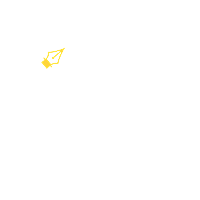Il tuffatore
Inizia ad accadermi già sul vaporetto. Divento isola mentre mi dirigo verso l’isola. Mi chiudo in un ventre di silenzio e resto incantata davanti agli oblò della nave. Guardo come al cinema ciò che mi scorre davanti e non c’è madre apprensiva, e non c’è figlio ribelle, e non c’è bagnante annoiato. Nulla può distrarmi.
L’isola mi stanca. Il suo sole cocente sulla nuca mi stanca. Il suo mare, l’andirivieni delle sue onde, il loro morire sulla battigia dopo aver brillato di luce mi stanca. Lunghe dita a sgranare rosari, preghiere che si impigliano sulle labbra, le processioni del santo, i caffè sul porto, le mura scrostate dalla salsedine, le luminarie sul vicolo di pietra, le reti dei pescatori, i polpi catturati a mani nude dagli scugnizzi, le loro urla, i panni appesi sui muri di calce bianca, le piante grasse, le insegne del patrono, le insegne di Maradona, i riflessi di luce sulle onde mi stancano.
O forse l’isola accoglie una stanchezza che trascino da un impietoso altrove. Situazioni, persone, luoghi sbagliati in tempi stanchi e disattenti. A volte la vita porta alla deriva. Si diventa, in modo inevitabile, isole.
Nella casa al mare, passo il tempo sul letto, immobile, da mattina a sera, fino al confine del giorno con la notte più ebbra, ai suoni della festa, i fuochi a mare, alle canzoni cantate a squarciagola e mi addormento con la ninna nanna della vita che altri vivono, del mondo che brucia delle sue pulsioni, delle sue amicizie sfrenate, dei suoi amori passionali oltre me, senza me.
Immagino chi abita queste vite. Non assomiglio a loro. Nell’ombra del mio riposo non ho più connotati. I miei contorni sbiadiscono, divento segno che si cancella, su cui si passa disattenti con il palmo della mano mentre si scrive altro.
Mi chiedo di cosa io sia fatta. Di vuoto, forse. Di aria che diventa viziata. Del mio capo sul petto. Del mio fissare uno schermo, avanti e indietro tra app e social. Di perle di sudore accumulate tra mento e collo. Di testa pesante. Di respiro affannoso.
Sono una regina stanca, in prigione. Una Maria Stuarda accarezzata dalla brezza di mare. Indosso sfatta la mia corona di ore morte. Le accumulo con disattenzione. Il tempo si infila lento e va via veloce tra le mie dita.
A volte dalla finestra scruto il tuffatore. È un ragazzino mingherlino, cotto di sole e rosicchiato dal sale. Silenzioso, diverso dagli monelli del porto, si arrampica sugli scogli che lambiscono i muretti a secco di casa mia. Solo un tuffo, non di più. La schiena curva mi mostra la spina dorsale tanto è magro e mi fa pensare a un animale preistorico, un grosso, bruno lucertolone. Mi chiedo sempre se si accorga di me, del mio spiarlo. È l’unico contatto, seppur silente e lontano, con il mondo.
Avvolta nell’ombra, scruto il suo arrampicarsi tra i rovi. Non ho una visione distinta del mare, né di lui. Lo trovo a brandelli, ridisegnato dalla vegetazione. Raccolgo, un pezzo per volta, la sua schiena bruciata, il suo volto scavato, le sue gambe piene di graffi. Se lo vedessi nella sua interezza potrei anche innamorarmi e avere qualcosa per cui aspettare. Aspettare lui. Il suo arrampicarsi sulla roccia come camminare sui chiodi. Il suo equilibrismo che, con una smorfia in viso, si muove sul filo del pianto. Aspettare il suo tuffo.
Aspettare per tutta la giornata qualcosa sarebbe comunque vivere, anche se vivere non è. Sarebbe comunque desiderare, anche se desiderare non è. Sarebbe amare, anche se amare non è. Ho sempre pensato che nell’attesa si raccolga l’amore.
Nella mia vita non ho avuto grandi amori. Non conoscono, i miei occhi, quella scintilla di nostalgia di quando si parla di qualcosa che si è amato, per cui si è combattuto e che si è perso. Ma spicchi di qualcosa che amore non è, ma che all’amore un po’ somiglia, li ho raccolti nelle attese. L’attesa di una persona alla fermata di un bus, di un collega alla fotocopiatrice, di un amico alla mensa dell’Università. Li ho reputati come grandi amori in serate di confidenze annoiate quando, per consolare, ho dovuto fingere di avere una minima esperienza del mondo anche io.
Il tuffatore è una virgola di inchiostro ingoiata dall’acqua.
Il tuffatore è figlio del mare, una scaglia di sale, ramo secco plasmato dalla brezza.
Il tuffatore è nato su un assolo di chitarra intrisa di malinconia.
Mentre si cala in mare, grida di paura e sofferenza e divertimento e speranza. Nel suo tuffo stipa tutta la sua vita, ma anche qualcosa che non si può nominare.
Qualcosa che nome non ha, come questo mio essere stesa nel buio, per intere giornate, in questa isola dove sono in vacanza, a fare nulla, stremata.
Per le strade, in spiaggia, al mare mi sentirei scrutata. Il sole mi gratterebbe la pelle, il caldo mi soffocherebbe. Il mio letto è il solo porto a cui attracco per giorni interi.
Da queste giornate in solitudine esco intontita. Articolo male le parole quando mia sorella mi chiama verso sera. Ma cosa hai? Balbetti? Quasi non sei tu, dice. È il mare, mi instupidisce, lo sai.
Immagino che l’isola ci guardi, me e il tuffatore. Lui che si arrampica su uno scoglio rovente, io immobile su un letto coperto di ombre. Lui scuro, io diafana. Lui sicuro, io distratta. Lui che tenta di ripetere un gesto irripetibile, io che sfioro con gli occhi le cose fuori dalla finestra.
Io e il tuffatore, un arcipelago di solitudine.
Immagino l’isola ragionare: se solo il tuffatore facesse correre lo sguardo oltre l’intrico di rovi e sterpi che lo dividono dalla camera da letto della donna stesa, e se solo lei parlasse, o tossisse, o facesse anche solo un impercettibile mugugno, il tuffatore potrebbe cogliere schegge di lei uscire dal buio, e poi, e poi? Parlarsi, magari, o chiedere, ma chiedere cosa? Uno dei due avrebbe il coraggio di…?
Le risponderei di no. Non riuscirei. Anche se penetrasse il mio buio, vorrei solo scomparire. Il tuffatore è una minaccia, per me, che voglio solo essere.
Essere immobile. Senza un obiettivo se non quello di arrivare a cena, dormire e ricominciare. Vuota. Senza senso.
Il tuffatore un senso lo ha, invece. Si tuffa da uno scoglio che sembra conoscere solo lui. Ogni giorno. Come un rituale. Qualcosa che deve essere ripetuto perché di vitale importanza. Un solo tuffo, a un’ora certa, nel primo pomeriggio.
Cerco di immaginarlo altrove, non ci riesco. Ai tempi dell’università giocavo a inserire i professori che più temevo in luoghi diversi da una cattedra, tentavo di renderli più familiari immergendoli in una casa disegnata con pochi dettagli, qualche sfumatura di colore, amici in un giardino, luci in una sera d’estate. Con il tuffatore ho cercato di fare lo stesso ma con scarsi risultati. Per me vive solo piegato su quella roccia.
Da dove viene? Perché si tuffa in un punto così pericoloso della costa? Perché solo una volta? Perché tutti i giorni? Perché da solo? E poi dove va? Dove è la sua casa? Di cosa è fatta la sua vita? Come sono i suoi fratelli e le sue sorelle? Gli somigliano? Che abitudini ha? Gli piace andare al cinema? È innamorato di qualcuno? Quanto è grande il suo mare? C’è un posto a cui vorrebbe tornare?
Non incorniciato dalla mia finestra, diventa impalpabile.
Eppure presenza per me lo è. Nel nostro piccolo arcipelago lui è isola ricolma di gioia che onora con un rituale il tempo presente, io isola che attende, paziente, languida, un tempo futuro che col suo mare la sommerga.
A illustrare: foto di Deborah D’Addetta