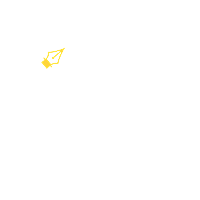Interdit
Era proibito. Nessuno lo diceva mai a voce alta, ma tu l’avevi capito. Quando nella roulotte di nonna Dana si accendeva la tv e per caso veniva fuori un film ambiguo, lei sbatteva il telecomando sulle ginocchia, si faceva il segno della croce e poi cambiava subito canale; quando capitava di andare a Le Marais o a elemosinare davanti alla Basilica del Sacro Cuore, e passavano delle coppie – non quelle normali, quelle “storte”, come sentivi dire tra i gitani – ti toccava distogliere lo sguardo, sennò il bibaxt, il maleficio, ti si sarebbe attaccato addosso.
C’est interdit! mimavano le mani delle donne del campo, mentre lanciavano gocce d’olio in piatti colmi d’acqua, chiavi di ferro, forbici, coltelli, ex voto; c’est contre Dieu! gridava con gli occhi il Patriarca Serein, che tu detestavi e avresti voluto vedere in un fosso a pancia in giù perché era obeso, indolente e puzzava di piscio e cipolla, ma che tutti rispettavano perché, insomma, era il capofamiglia, il phuro, il giudice del vostro Kriss, quello che la gente chiamava “tribunale”, ricco sfondato, sentivi sempre dire che cacava su una tazza placcata d’oro; tutti tranne te, perché per colpa sua i tuoi erano in galera. Così vanno le cose qui, ti convincevi, dopo aver visto le scudisciate che aveva preso sulla schiena Tamas da suo padre, per una colpa che avevi intuito, ascoltato a spezzoni tra i sussurri della tua gente, perché certe cose non si potevano nemmeno pronunciare, portava sfortuna. Me ne fotto, sembrava dire invece lui, Tamas: camminava tra le roulotte con passo orgoglioso, sorridendo tra i denti, il codino ondulato che gli spazzava le spalle e gli stivali perennemente sporchi di fango.
Era tuo cugino per parte di madre, ma nel campo eravate tutti cugini.
Ti piaceva Tamas: era grande, era bello, ci sapeva fare con le macchine ed era capace di tirare su una baracca in due ore se aveva tutto ciò che serviva – mattoni, lamiere, travi di legno – e in più, ciò per cui ti era tanto caro, aveva difeso tua madre e tuo padre quando era stato il momento.
In quel periodo vi eravate insediati nella periferia a nord-est, nei pressi del dipartimento di Seine-Saint-Denis, sotto il cavalcavia di Rue du Parc: davanti al campo passavano i treni della RER diretti alla stazione di Parigi Est, per cui giorno e notte, notte e giorno, eri costretto ad ascoltare lo sferragliare intollerabile delle ruote sui binari. I parigini vi chiamavano manouches se andava bene, gitanes de merde se andava così così, passavano direttamente alle bastonate o alle roulotte bruciate di notte se andava male. Capitava spesso che arrivassero anche i poliziotti con decine di volanti, che chiedessero di parlare col Patriarca con la scusa dei censimenti e poi facessero comunque di testa loro, prendendo a calci, spaccando qualche roulotte o semplicemente minacciando di sgomberare.
Di Parigi conoscevi pochissimo, la maggior parte del tempo la passavi nel campo tra i pantani, l’immondizia, la puzza di plastica e legno bruciati e le casupole delle famìlje, nient’altro che un groviglio di lamiere, travi marce e mobili pescati dalle discariche. Avevi un cane, Mangò, un vecchio pastore tedesco pieno di pulci che ti seguiva ovunque. Tua nonna Dana non voleva che entrasse nella roulotte, diceva che la Vergine Nera non amava i cani. Tu non sapevi chi diavolo fosse questa vergine, ma conoscevi il suo volto perché ti guardava dal suo altarino posto appena sopra la tv, affollato di nastrini, mozziconi di candele, bicchierini colmi di alcool diventato ormai aceto. Ogni tanto le lanciavi uno sguardo timido, ti faceva paura con quella pelle color cuoio e la corona piena di gemme ma vuota di grazie.
Sapevi che si chiamava Sara-la-Kali, Sara la Nera, e non avevi ben capito se fosse davvero una madonna o una di voi, una gitana. Avevate dei parenti in Camargue, un altro ramo del vostro clan, che andavano in pellegrinaggio in suo onore a Saintes Maries de la Mer. Tamas ci sputava contro e la bestemmiava in continuazione. Tu avresti voluto ridere, ma non avevi alcuna intenzione di essere picchiato.
Tamas era promesso a Lala, sua cugina di secondo grado, da quando entrambi erano in fasce. La famiglia di lui aveva pagato la dote della sposa in modo piuttosto generoso – Lala avrebbe dovuto risarcirla diventando una moglie e una madre esemplare – cedendo collane d’oro, un paio di auto e delle coperte ricamate di lana colorata. Il Patriarca Serein aveva dato la sua benedizione spruzzando di vino le fedi e lanciando una manciata di banconote in aria.
Tamas e Lala dovevano sposarsi in estate e la famiglia di lei aveva già messo in bella mostra l’abito da sposa dentro la loro roulotte, perché tutti andassero a vederlo e a benedirlo. C’eri andato anche tu con nonna Dana, eri rimasto inorridito e affascinato dall’imponenza della gonna, dalla ricchezza del pizzo, dalla lunghezza del velo.
Lala non era bella: era alta e magra, di carnagione olivastra, e aveva degli occhi così neri che facevano paura. I capelli annodati e crespi le finivano sulla schiena come cordoni. Le donne del campo dicevano che era nata holypi, che era una strega, e perciò non bisognava farla arrabbiare. A Tamas non fregava niente neanche di quello. A Tamas, tu lo sapevi, l’avevi visto coi tuoi occhi, fregava solo di Andrej.
Era marzo, aveva appena smesso di piovere, i treni continuavano a sfrecciare entrando e uscendo da Parigi. Il campo era immerso nella luce giallastra dei lampioni, rigagnoli fangosi si infiltravano nelle tende, negli interstizi delle porte. Da qualche parte, al di là dei tetti di lamiera, saliva al cielo del fumo denso e grigiastro che lambiva i piloni di cemento del cavalcavia. Riconoscesti la puzza di ciarpame bruciato, evidentemente qualcuno sentiva freddo e aveva acceso un fuoco improvvisato. Dalla roulotte di nonna Dana si sentiva la sua risata grassa, da trombone: a quell’ora sapevi che stava guardando il suo programma preferito, una specie di show a puntate in cui la gente cantava e ballava per guadagnare soldi.
Che idioti, pensasti.
Perciò, giravi per il campo col tuo cane, cercando di impiegare il tempo: tra i cumuli di immondizia che producevate non c’era nulla di valore, sentivi freddo e avevi anche un po’ fame, ma non avevi alcuna voglia di andare da nonna Dana o nella grande baracca comune dove Serein leggeva passi della Bibbia, ruttando tra un versetto e l’altro.
Seguisti Mangò ai margini del vostro territorio, laddove erano raccolte le tende più piccole e le catapecchie delle famìlje più povere. Superata l’ultima ti fermasti: il passaggio di un treno aveva coperto ogni altro suono, ma il cane aveva alzato le orecchie e aveva puntato il muso verso una piccola roulotte disabitata.
Non aveva più le ruote e la scaletta che dava accesso alla porta d’ingresso era mezza sfondata: era già lì quando eravate arrivati a Parigi e le donne avevano detto che era appartenuta alla famiglia di un altro gruppo gitano e per questo doveva restare inviolata. Mangò trotterellò proprio in quella direzione. Ti avvicinasti, ti sembrò di sentire un lieve rumore, come di fogli spiegazzati. Girasti intorno alla roulotte, poggiasti l’orecchio sul legno freddo, mentre Mangò perdeva interesse e cominciava a rotolarsi nel fango.
Ti sembrò una cosa furba evitare di fare rumore, così, spostandoti in punta di piedi, ti mettesti a cercare un buco tra gli assi. Volevi guardare dentro, decifrare quel rumore. Passò un altro treno, ingoiasti la saliva che stavi per sputare a terra in segno di sdegno. Finalmente una piccola cicatrice aperta: entrambe le mani sul legno, le ginocchia un po’ piegate, il ciuffo di capelli che continuava a caderti sulla fronte, riuscisti a intravedere nella penombra della roulotte due corpi seminudi che si muovevano piano. Riconoscesti immediatamente il codino di Tamas, il suo tatuaggio, un elefante e una croce che si snodavano come sciogliendosi sui muscoli dell’avambraccio sinistro. Teneva addosso la camicia a quadri, una collana spessa al collo, ma il pantalone gli era scivolato sulle caviglie. Si muoveva con cadenza regolare contro un altro corpo piegato in avanti. Il rumore che avevi sentito non erano fogli, ma i suoi gemiti sussurrati, volutamente controllati. Riconoscesti anche l’altro, ma con qualche minuto di ritardo: era Andrej, il fratello di Lala.
Spartivano, lui e la sorella, gli stessi occhi di lupo, la stessa pelle, la stessa corporatura scattante e nervosa. Riuscisti a vedergli le spalle, la pelle elastica che si tendeva sulle scapole, i suoi capelli ricci e nodosi che, però, non erano sufficienti a coprirgli il viso. Teneva la bocca aperta in un’espressione beata, la stessa della Vergine Nera.
Pensasti che era un sacrilegio. Avevi già visto fare le stesse cose ai tuoi genitori, ma loro erano sposati ed erano uomo e donna. Così invece era proibito! Interdit! Contre Dieu! Eppure, nonostante lo sgomento, continuasti a guardare fin quando Tamas non aumentò la velocità, le mani artigliate sui fianchi di Andrej, il codino ciondolante, il tatuaggio che pareva parlare, per poi emettere un suono strano alle tue orecchie, un suono che ti sembrò un grugnito animalesco e un sospiro di sollievo e, forse, un singhiozzo abortito.
Distogliesti lo sguardo per un attimo, distratto da un fruscio, un’ombra saettante alle tue spalle. Indugiare tra i cespugli, la luce gialla e tagliente che veniva dal cavalcavia, non ti procurò alcun indizio utile. Probabilmente avevi immaginato quel lieve sfarfallio. Poi il sollievo di vedere comparire Mangò, con un bastoncino tra le zanne. Non ti accorgesti che c’era davvero qualcuno che ti osservava osservare.
Prima che Tamas ebbe modo di voltarsi, tu fuggisti via.
Era proibito, era proibito!, questo continuavi a ripeterti, mentre il cane correva al tuo fianco. Quella notte sognasti Tamas e Andrej e Sara-la-Kali e il bibaxt che ormai, eri convinto, ti si era attaccato addosso.
La mattina dopo nonna Dana ti scosse bruscamente nel letto.
«C’è Krisnitori, sbrigati» sussurrò.
Trovasti il Patriarca seduto a tavola, nel bel mezzo della roulotte, con una tazza di caffè in mano. Ti sembrò stranamente minaccioso quando ti domandò di sederti di fronte a lui, la sua faccia piena di buchi e di cicatrici. Domandò come stavi, come andava la vita, se ti mancassero i tuoi genitori. Per poco non gli lanciasti la caffettiera addosso, o almeno pensasti di farlo: ricordavi perfettamente quando, tre anni prima, lui non aveva mosso un dito mentre la gendarmerie portava via tua madre e tuo padre, accusati di traffico di minori. L’avevi visto leccare il culo al loro capo, scusarsi persino. Solo Tamas gli aveva detto in faccia che era un vigliacco, che nel clan dovevamo proteggerci l’uno con l’altro e quello che aveva risposto? che pensava alla comunità, che era meglio che si prendessero due di noi piuttosto che tormentare tutti quanti.
«Dove sei stato ieri sera?» ti chiese, all’improvviso.
Mentre apriva la bocca gli brillò un dente d’oro. Tu pensasti velocemente a cosa dire, mentre nonna Dana ti guardava con gli occhi preoccupati. Potevi quasi sentirla dire “sbrigati, sbrigati!”, ma tu non avresti tradito Tamas, mai.
«In giro nel campo, con Mangò.»
«Hai visto qualcosa di strano?»
«Strano come?»
Il battito del tuo cuore ti palpitò nelle orecchie. Avevi un terribile sospetto. Che anche lui sapesse? Si appoggiò alla spalliera della sedia e incrociò le braccia tozze sulla pancia, i polsi stretti tra decine di braccialetti di perline. Aspettò.
«Non ho visto niente, solo qualcuno di noi che si scaldava con un fuoco.»
Il patriarca ti soppesò, dondolando la testa avanti e dietro. Alla fine sorrise. Il dente brillò di nuovo. Si allungò verso di te e ti scompigliò il ciuffo.
«Bravo ragazzo, babo Dana ti ha cresciuto per bene a te.»
Prima di andarsene però, puntò il dito sulla statuina di Sara-la-Kali.
«Lei guarda sempre» sussurrò, il fetore del suo alito sul tuo viso, «Se qualche volta non sai quello che è bene e quello che è male, chiedi a lei.»
Lui aveva finito con te, ma tu non avevi finito con lui.
«È vero che hai un cesso tutto d’oro?» chiedesti.
Tua nonna Dana si alzò di scatto, già pronta con il braccio levato per colpirti, ma lui la bloccò con un’occhiataccia.
«Certo che ce l’ho» rispose quello, «E sai perché ce l’ho? Perché sono furbo. Se anche tu quando ti fai grande vuoi un cesso d’oro, impara a essere furbo.»
Si alzò, ringraziò nonna Dana, e tu fuggisti via prima che lei ti riempisse di botte. Volevi assolutamente andare da Tamas ad avvertirlo, ma come? Avrebbe voluto dire confessare di averlo visto con Andrej. La vergogna ebbe la meglio e tu tacesti. Eri stato bravo però, avevi tenuto il segreto.
La mattina dopo non ti svegliò il Patriarca, ma un grido.
Scendesti dal letto, uscisti dalla roulotte a piedi nudi, seguisti la folla. Tutti sembravano dirigersi verso il cumulo di immondizia ai margini del campo. Qualche donna urlava, una su tutte, una giovane, nemmeno quarant’anni, con un fazzoletto a fiori in testa, dei grandi cerchi d’oro alle orecchie e la gonna a fasce marroni e blu. Era la mamma di Andrej – la mamma di Lala – e scavava con le mani ingioiellate tra i sacchi di lerciume. Lo vedesti anche tu, qualche minuto dopo, facendoti largo tra le gambe della gente: un corpo completamente nudo, evirato, un foro nella tempia, una pozza di sangue che aveva intriso il terreno e i rifiuti, la testa dolcemente appoggiata su un sacco nero. I riccioli si confondevano tra la plastica, gli occhi erano aperti, guardavano il cielo grigio di una città che non era Parigi.
Sua madre urlava come un’ossessa. Mangò guaì, forse contagiato dalla disperazione della donna. Lala non si vedeva da nessuna parte. In compenso, arrivò Tamas.
Prese a calci e pugni chiunque gli si mettesse tra i piedi, spinse via anche la madre di Andrej, poi si chinò sul corpo dell’amico, dell’amante – non sapevi come definirlo – e lo afferrò, stringendogli le carni come gli avevi visto fare due sere prima. Lo abbracciò, poi lo guardò, percorse con gli occhi le spalle, il torace, il ventre, il pube che era ormai un buco nero, le gambe, baciò il buco sulla tempia e il suo sangue rappreso. Urlò contro il cumulo di spazzatura, poi urlò contro di noi, sputandoci addosso, promettendo vendetta, bestemmiando contro Dio e quella puttana lurida di Sara-la-Kali, così disse.
Ti domandasti, preso dal panico, se sapeva che tu sapevi.
Nonna Dana, quella sera, davanti alla solita trasmissione chiassosa e a un piatto di polpette speziate e verza bollita, parlava da sola, dicendo che Andrej se l’era cercata e che era già tanto se non avevano ammazzato anche Tamas. Quelle cose non dovevano succedere, diceva, mangiando con la lingua che saettava di fuori, era stata Lala a fargli una fattura, perché era una holypi e non bisognava farla arrabbiare. Tu volevi obiettare, allora apristi la bocca per dire che non era giusto, che Andrej e Lala erano fratello e sorella, ma nonna Dana non ti permise di continuare: ti colpì il viso con un manrovescio micidiale, spaccandoti il labbro inferiore con il suo anello.
C’est interdit! lampeggiò con gli occhi, chiudendo la questione.
Di notte, aspettasti che lei si fosse addormentata per tornare alla roulotte. Quella volta c’era solo Tamas che piangeva, abbandonato a terra, di fianco, come una marionetta senza fili. Venne da piangere anche a te, ma ti allontanasti, dirigendoti con Mangò verso l’immondezzaio. Fermandoti ai margini, ti accorgesti che il corpo di Andrej non c’era più, era rimasto solo il suo sangue nella polvere che alla luce dei lampioni gialli del cavalcavia ti sembrò nero.
Sapevi che tra la tua gente c’era l’usanza, quando qualcuno moriva, di tenere il corpo al riparo tra i familiari per tre giorni: gli uomini si ubriacavano, le donne cucinavano e pregavano e i bambini offrivano cesti di frutta. Per Andrej tutto questo non accadde: quando passasti di fianco alla roulotte della famiglia di Lala, la trovasti buia e silenziosa. Ti domandasti dove avessero portato allora il corpo di Andrej.
Poi di nuovo, come l’altra volta, un fruscio alle tue spalle, un’ombra spezzata. Non ci badasti, ti rodeva il rimorso di non aver parlato con Tamas, di non avergli detto della tua strana conversazione con Serein.
Il matrimonio di Lala e Tamas si svolse come previsto, in estate, col rumore dei treni RER che sfrecciavano dentro e fuori Parigi. Il vestito della sposa era ancora più impressionante visto indossato. Sua madre evidentemente pensava ancora a suo figlio perduto perché, accompagnando Lala tra gli ospiti, piangeva e non di gioia.
Dappertutto c’erano nastrini rossi, bandierine rosse, tovaglie rosse, cesti di frutta rossi. A te ricordavano i rivoli di sangue che si allontanavano dal corpo nudo di Andrej.
La musica dal vivo risuonava nel campo, la festa sarebbe durata tre giorni. Tu ti annoiavi, non ti interessavano il cibo, il vino, gli scambi di doni e la cerimonia dell’esposizione del lenzuolo della vergine.
Ti scervellavi domandandoti chi diavolo avesse ucciso Andrej.
Ti sedesti per terra, su un tappetto, osservando tutti: tua nonna Dana, grassa e ridanciana, mangiava senza contegno; il papà di Tamas, quello che l’aveva picchiato a sangue con una cinghia appena l’anno prima, era ubriaco marcio, svenuto ai piedi di un tavolo, con una bottiglia di vino in una mano e un coltello sporco di sangue nell’altro. Sapevi della tradizione di tagliarsi i palmi delle mani durante un matrimonio, ma non volevi soffermarti su quel pensiero; la mamma di Andrej e Lala era seduta tra decine di donne, abbigliata come una regina, ma triste come l’ultima delle miserabili. Guardava sua figlia ballare con i nuovi parenti e cugini acquisiti, gli occhi acquosi e la bocca serrata.
E Lala infine, i capelli neri raccolti in un’elaborata acconciatura a forma di nido d’uccello, tutta puntuta sulla testa, il velo lunghissimo ormai sporco di fango e terra, i piedi nudi e il sudore che le rendeva la pelle del petto e del collo lucida.
Ballava come una dannata, mentre Tamas la osservava di sottecchi da lontano, la faccia da martire. D’improvviso lei si voltò verso di te, o almeno così ti sembrò, ti rivolse un sorriso sghembo, il suo incisivo d’oro brillò per un istante. Alzò la mano per salutarti, si toccò una collanina al collo. Poi, uno scherzo della luce o un’allucinazione, il suo viso diventò scuro, i capelli si sciolsero e con quel velo, con quegli occhi, per una frazione di secondo assomigliò a Sara-la-Kali.
Cadesti all’indietro, lei continuò a sorriderti, fissandoti con insistenza.
Una mano t’impedì di battere le spalle a terra. Avvertisti il suo odore acido ancora prima che ti toccasse, ma l’aver fissato Lala ti aveva distratto. Serein si avvicinò e ti strinse il braccio. Ti disse che eri un bravo bambino, che nonna Dana ti aveva cresciuto nel timore per le vostre tradizioni e le vostre usanze, che sapevi quando parlare e quando no.
Quando ti voltasti per guardarlo, il suo viso butterato e paonazzo aveva la stessa espressione di Lala: sorrideva, toccandosi una medaglietta al collo. Mangò cominciò a ringhiare, non gli piaceva che qualcuno ti stesse così vicino.
La medaglietta raffigurava una Madonna nera.
«Mai sputarci contro, Ivan» disse, «Tu lo sai che è proibito, vero?»
Era la prima volta che qualcuno lo pronunciava a voce alta, tu però non lo sentisti perché un treno diretto a est passò proprio in quell’istante. Lo stesso in cui Tamas si staccò dal muro, s’infilò la mano nel pantalone e tirò fuori una piccola pistola dalle volute dorate, quasi ti sembrò un giocattolo.
«Anche questo è proibito?» urlò, prima di puntarsi la pistola sotto il mento e sparare.
Gli schizzi di sangue arrivarono fino alla gonna bianca di Lala, al viso del padre e alle damigelle sedute in cerchio su un altro tappeto, tutte vestite di fucsia acceso.
Questa volta fu Lala a urlare, mentre Serein si faceva perno sulle tue spalle per alzarsi e raggiungere Tamas, e sul viso di sua madre, la madre di Andrej, andava morendo la malinconia e si allargava un sorriso bestiale.
A illustrare il racconto: una fotografia di Sabine Weiss, Saintes Maries de la Mer, Francia, 1960.