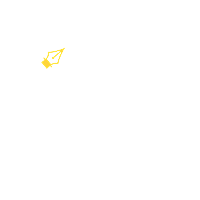Spaghetti alla puttanesca pt.2
Nello studio trascorre quasi un minuto di silenzio, dopo che Gaudì ha finito di raccontare la sua versione degli spaghetti alla puttanesca. Per tutta la durata della storia Mariella ha continuato a sventolarsi senza sosta col foglio della scaletta: desidera da sempre che qualcuno le mangi addosso un bel sugo caldo mentre la possiede senza misura, purtroppo però non è mai andata oltre qualche banalissima dose di panna. Nemmeno la nutella si è mai concessa: troppo dolce per i palati dei suoi amanti.
Dopotutto in questo mondo ci sono solo tre piaceri: mangiare, scopare e gonfiare lo share, perché non usufruire il più possibile di tutti quanti? Magari pure contemporaneamente.
Gli applausi di Diocleziano dissolvono i suoi sogni.
«Ao, bella storia Gaudì, bella ‘na cifra. Che poi cioo sanno tutti che ‘o piji in der culo, però da come la raccontavi pareva quasi te piacesse la fregna. Nun te facevo così zozzone!»
Gaudì arrossisce. «In realtà mi piace assaggiare tutto, comunque grazie.»
«Peccato solo ‘na cosa.»
L’imbarazzo del cuoco si trasforma in un sopracciglio alzato. «Cosa?»
«Che so’ tutte fregnacce, Gaudì. Me piagne er core a dillo, ma la puttanesca non è romana proprio pe’ niente. L’hanno inventata giù a Ischia e c’è de mezzo pure ‘na francesina, pensa te.»
«Non so se ho davvero voglia di sentire le tue farneticazioni, ma tanto non riuscirò a fermarti.»
Spunta un sorriso sornione sul volto di Diocleziano, sempre più simile a una versione coatta di Romeo degli Aristogatti.
«Se capisce. Però, già too dico, stavorta c’è poco da scopa.»
La Mariella nazionale si rianima, sconcertata: «Come sarebbe?»
«A Dottore’, lo dovrebbe sape’ che co’ le donne nun se pò solo pija, alle volte bisogna pure pati’.»
«Dipende che donne trova» ammicca lei.
In risposta lo chef le stringe la mano: «Stia a vede’ che storia le apparecchio, Dottore’.»
Mariella avvampa.
«Lo prometto: sarà tutto un palpita’!»
Dopo la fine della seconda guerra mondiale, se volevi spassartela a Ischia, il “Rangio Fellone” era il posto che faceva per te.
Un piccolo recinto di sassi che guardavano il mare, protetti dalle chiome fitte della pineta Mazzella. Bastò questo all’architetto Petti per radunare una folta umanità che ogni sera si riuniva per bere, ridere e amare, cullata dal rumore delle onde che s’infrangevano sugli scogli e dalla chitarra di Ugo Calise, musicista ufficiale del posto nonché canzoniere ambulante.
L’abilità con le sei corde di Calise non si discuteva; e così, complice anche la posizione paradisiaca individuata da Petti, personalità importanti come Angelo Rizzoli e artisti blasonati come Luchino Visconti diventarono clienti abituali. Una volta Manlio Brosio, ambasciatore italiano a Londra, propose a Calise di suonare per la Regina Elisabetta II. Proposta allettante, se non fosse che l’unica sovrana a cui il musicista – per altro indefesso sciupafemmine – aveva giurato fedeltà era quella stessa luna che ogni notte guardava cantando ‘Na voce, ‘na chitarra e ‘o poco ‘e luna. Il suo brano più richiesto, noto per fare sospirare ogni ragazza e un poco sperare ogni ragazzo.
Solo una donna riuscì a incrinare quella relazione così esclusiva. Quella giovane francese era capitata quasi per caso: una mattina infatti l’architetto Petti l’aveva trovata davanti alle porte del locale, come fosse stata recapitata dal mare. In lacrime, col volto livido e le vesti strappate, doveva avere poco più di vent’anni. Nessun documento con sé, non parlava una parola d’italiano, figuriamoci di napoletano. Solo il suo nome riusciva a pronunciare: Yvette.
Petti pensò a una donna di strada, arrivata sull’isola chissà come, magari malmenata da un cliente o dal suo stesso magnaccia. Non era un uomo in cerca di guai, ma si lasciò intenerire da quegli occhi da cerbiatta, così portò Yvette dentro al locale e le dette un posto dove dormire e un nuovo lavoro. Del resto una cameriera carina in più era sempre una fortuna per un’attività come la sua. E Yvette carina lo era davvero: fine tanto di caviglie quanto di modi, con dei riccioli corvini che le si arrotolavano naturalmente sopra al naso e due labbra disegnate per un bacio. La lingua per lei non sembrava essere un problema, tanto che in breve divenne la ragazza che scuciva le mance migliori, attirandosi le antipatie di tutte le altre cameriere, che l’avevano soprannominata la puttanella del capo o, con una qualche licenza poetica, la puttanesca.
“Na voce, na chitarra e ‘o ppoco ‘e luna
E che vuó’ cchiù pe’ fá na serena…”.
Il verso si spezzò in bocca a Calise la prima volta che intravide il grembiulino celeste di Yvette girovagare per i tavoli col vassoio dei cocktail in mano. Concluse l’esibizione alla meglio, poi si prese una pausa, promettendo al pubblico un bis, quindi corse dalla nuova arrivata per presentarsi. Di solito erano le altre a venire da lui, eppure quella volta, in quegli occhi nocciola non riconobbe ammirazione ma stupore: Yvette non solo non aveva alcuna idea di chi fosse, ma non capiva nemmeno quello che diceva.
Un uomo normale si sarebbe scoraggiato, al contrario per Calise fu subito amore: finalmente un essere tanto bello, distante e puro, come la sua amata luna. Da quel preciso istante, l’artista fece del conquistare il cuore della ragazza una missione. Una missione che doveva avere – e di questo si convinse da solo – i colori, i suoni e i sapori di Ischia. Dopotutto Yvette era una straniera, aliena a quei luoghi, per toccarle il cuore la sua chitarra non sarebbe bastata: c’era bisogno che la donna si aprisse prima al mondo che Calise cantava e celebrava ogni sera nelle sue canzoni.
Non perse tempo: la mattina dopo passò a prenderla in sella a una vespa. Yvette non ebbe nemmeno modo di protestare che in quattro e quattr’otto gli si ritrovò avvinghiata dietro. La vespa scese dall’antica strada che collegava il paese di Testaccio alla baia dei Maronti, fino alla spiaggia dove la ragazza si incuriosì osservando la calca delle pesciaiole stretta intorno alle barche dei pescatori. Le donne riempivano le ceste fino all’orlo e prima di avviarsi verso la piazza del mercato, salutavano i mariti con un bacio o con un improperio, a seconda dell’umore. Assunta e Mari corsero incontro a Calise che si era avvicinato mano per mano a Yvette. Si complimentarono con la ragazza con frasi che lei non comprese, ma che bastarono per farla arrossire, e offrirono alla coppia due fette di pane con pesce crudo condito da acqua di mare. Una perfetta colazione isolana, che arrivò al palato della bella francese in tutta la sua sapidità, mentre i pescatori, in coro, le dedicavano Ué, Ué, Che Femmena, subito rimessi in riga dalle occhiatacce delle mogli.
La strada per il mercato era lunga, anche se per le pesciaiole non era mai stato un problema: se la facevano ogni giorno avanti e indietro, con qualche kg di pesce sulle spalle che provavano a vendere lungo il tragitto. “Aluzz, aluzztiell frische!” urlavano alle altre donne del paese, radunatesi per aggiudicarsi il pescato migliore. Yvette doveva trovare buffo quel richiamo perché non la smetteva di ridere vicino a Calise, anche lui messo a faticare con una cesta in mano, mentre le mostrava la differenza tra un sarago e una triglia.
La piazza del mercato si lasciò annunciare da una sarabanda di suoni e colori. Bambini dai calzoni corti giocavano a rincorrersi, maledetti dalle pesciaiole che intanto scaricavano il pesce sui banchi, in mezzo a contadini che urlavano per attirare gli sguardi sulla loro merce.
Yvette scansò all’ultimo un carretto malmesso tirato da un ciuchino altrettanto malmesso, diretta verso dei pomodori di un rosso così intenso da scaldare. Ne agguantò uno e gli attaccò un morso, col siero che intanto le colava dalla bocca fino allo scollo. Corse avanti dove, vicino a carciofi belli più di un fiore e una torma di cavolfiori giganti, rimase colpita da un tavolo di olive nere come crine di cavalli, proprio accanto ai capperi fieri con tutti i gambi all’insù. Calise osservava quella ragazza aggirarsi da un banco all’altro e nell’osservarla si innamorava ogni secondo un poco di più. Un musicista di strada riconobbe il cantante e gli si avvicinò intonando Maruzzella. Insieme cantarono il ritornello, col resto della piazza che cominciò a battere a tempo le mani:
“Stu core mme faje sbattere
Cchiù forte ‘e ll’onne
Quanno ‘o cielo è scuro
Primma me dice sí
E doce doce, mme faje murí
Maruzzella, Maruzzé”.
Quando, ore dopo, rimontarono sulla vespa, c’era ancora del succo di pomodoro a tingere di rosso le labbra di Yvette. Da quel giorno e per tutti i seguenti, Calise passò di buon ora a prendere la ragazza per farle fare un giro. La portò a vedere il tramonto sul picco di Santa Maria del Soccorso, protettrice dei marittimi, poi ad affondare le mani nella sabbia bagnata della spiaggia di Sant’Angelo, alle terme di Cavascura, con le loro tre fonti note anche ai romani, e ad assaggiare l’olio da un contadino grato a Calise per una vecchia fiamma, conquistata anni prima grazie a un suo pezzo.
Galeotto però fu un gozzo, che un pescatore suo amico gli aveva prestato. La coppia stava a largo, di fronte al mare color smeraldo della Grotta Verde. Calise smise di remare, si tolse la camicia e si tuffò in mare, invitando Yvette a fare altrettanto. La ragazza lo seguì. Gli schizzi zampillarono sopra i vestiti abbandonati sul gozzo. Yvette boccheggiò per il freddo, si fece vicina a Calise e gli mise le braccia intorno al collo. Senza distogliere gli occhi dai suoi, lui le chiese se sapeva cosa dicessero i napoletani in occasioni come quella. Lei scosse la testa, allora lui rispose: «Lassate vasà.»
Si baciarono e agli occhi di chi li avvistò da lontano sembrarono una cosa sola.
La notte stessa, quando la luna si apprestava a cedere il passo al sole, il “Rangio Fellone” era deserto mentre sul palco Calise stava sistemando la chitarra nella custodia. Alle sue spalle sentì un rumore di tacchi che si avvicinavano: era la prima volta che vedeva Yvette in abito da sera – non aveva idea di chi glielo avesse prestato – ma sotto quella luce, con dei fili sottili sulle spalle a tener su il vestito nero, sarebbe stato facile scambiarla per una diva del cinema. La ragazza lo prese per mano e lo scortò al centro del locale, lo fece sedere a un tavolo che aveva lasciato apparecchiato solo con le posate, i bicchieri e una bottiglia di vino bianco, poi sparì in cucina. Calise deglutì, stappò la bottiglia e riempì prima il bicchiere della ragazza poi il suo.
Il cielo intanto osservava la scena con gli occhi di un’infinita distesa di stelle.
Fu il profumo la prima cosa a sorprendere Calise: quell’odore isolano di olive, capperi e olio che si spanse per la sala fino alle sue narici. Poco dopo arrivò Yvette con in mano un piatto di spaghetti dipinti di rosso da un sugo che non aveva mai visto prima.
Lei sorrise, gustandosi la sua reazione stranita. Prese il bicchiere e dette una sorsata al vino, senza smettere di guardarlo. Calise era esterrefatto: non credeva che Yvette sapesse cucinare, inoltre non aveva mai visto un piatto simile. Sguainò la forchetta, arrotolò una manciata consistente di spaghetti sotto lo sguardo alcolico della francese e li portò alla bocca, famelico, nonostante l’ora fosse più prossima alla colazione che alla cena. La sapidità dell’oliva gli si sciolse in bocca, in un letto d’olio che faceva all’amore col pomodoro e l’origano. Nella sua semplicità quel sugo era un amplesso di sapori che sapevano di salmastro e di baci rubati vicino a un gozzo. Calise non riusciva a credere alle sue papille. Dette un’altra forchettata, poi un’altra e un’altra ancora, con Yvette che lo guardava e rideva, sorseggiando un bicchiere dopo l’altro. Mentre masticava Calise non riusciva a distogliere gli occhi da quelli della ragazza. Si accorse di esserne totalmente alla mercé, di dipenderne come le maree al cospetto della luna. Nel tentativo di ribellarsi da quell’incanto, si alzò, senza nemmeno aspettare di avere finito il piatto, e con ancora la bocca sbavata di rosso, si avventò su Yvette che lo accolse in sé. Nella foga, il bicchiere colmo di vino della ragazza si frantumò a terra.
Per il restò fu uno scampolo d’amore condiviso tra due corpi che avevano deciso di appartenersi fino al mattino.
Calise si svegliò quando il sole era già alto. Con la mano si coprì gli occhi, prima di accorgersi che l’unica cosa che gli era rimasta addosso era la camicia. Provò a chiamare il nome di Yvette, una, due, tre volte, senza ottenere risposta. Allora si alzò e perlustrò tutto il locale: la ragazza era sparita senza lasciare traccia.
Nessuno seppe più niente di lei, né al Rangio Fellone, né a Ischia. Dal nulla era apparsa e nel nulla si era dileguata.
Calise, da quel giorno, si rifiutò di suonare per una settimana intera, come se il suo sciopero potesse in qualche modo influire sul destino. Infine capì e allora tornò a dedicare canzoni alla luna. Non prima però di fare un’ultima richiesta all’architetto Petti: la sera del suo ritorno sul palco, sul menù del Rangio Fellone spiccava un nuovo piatto, gli spaghetti alla puttanesca, con un sugo a base di pomodoro, olive nere e capperi.
Per celebrare l’evento, Calise aprì la serata con un inedito che suonava così:
“L’ aggio ‘ncontrata,
e a primma vista lle parlaje d’ammore
mentre, ‘ncantata,
guardava ‘a luna ca luceva a mare.
E lle dicette: «Lassate vasà…»,
me responnette: «Je ne comprend pas!»”.
Gaudì guarda Diocleziano, che ha appena finito di parlare.
Diocleziano, dal canto suo, sta già guardando Gaudì da un bel po’. Non gli ha staccato gli occhi di dosso mentre raccontava.
Mariella Menchelli, povera anima, c’ha – come dicono a Roma – er cratere che je sbroda, ma non vorrebbe darlo a vedere. Si sta rapidamente immaginando a fare il prosciutto tra due fette di pane vestite da cuoco.
Fa per aprir bocca, ma Gaudì l’anticipa:
«…Anvedi che tajo, come direste qui. Diocleziano, gioia mia, io mica lo sapevo che c’era tutta questa poesia in quel Maciste che ti porti appresso.»
Ci siamo. Adesso si picchiano. E poi magari picchiano me, pensa Mariella. Ma Diocleziano, sempre fissando Gaudì, non si muove. Gli s’increspa l’angolo della bocca in un sorriso.
«Gaudì, tu me piaci. E chi se lo stava a crede! Eppure.»
«Dici?»
«Ma sì. Fai la checca isterica pe’ n’ora, che t’avrei staccato le gengive a mozzichi, e’nvece guarda te che storiaccie sode, zinnute che amo tirato fori. Te sei pieno de robba. Sei un vulcano. M’immagino quando vai a fa piagne er drago, che fatica a tirallo fori dalle brache. Pari così n’acqua cheta…»
Gaudì, sornione, si avvicina di qualche centimetro.
«Io lo avverto questo amore di cui parli, Diocleziano. Erano tanti anni che non lo sentivo e tu me lo hai fatto sentire di nuovo. Io non sapevo più amare, Diocleziano. Dovevo venire a impararlo da te.»
«Se hai bisogno de un ripasso, sai dove lavoro.»
I due si guardano. Mariella prova a intervenire: «E dopo queste storie meravigliose, è venuto il momento di…»
«Se semo visti» proclama Diocleziano, senza badarle.
Gaudì è perplesso. «Cioè, mi stai dicendo che ci separiamo?»
Diocleziano ride. «Ma vedi d’annattene.»
Gaudì, sempre più perplesso: «E tu non vieni…?»
Resosi conto del gap linguistico, Diocleziano usa la lingua in modo più creativo e la infila in gola a Gaudì, prendendo in mano la situazione e le sue chiappe.
«Signori, signori, per favore, questo è del tutto inappropriato!» esclama Mariella.
Gaudì, dal canto suo, gli allaccia le gambe attorno ai fianchi sodi e gli strizza i capezzoli, come se stesse abbrancando la tetta di sua madre, nell’eterna fame del neonato.
«Signori, siamo in fascia protetta, gli sponsor!» grida Mariella.
Diocleziano sbatte Gaudì sul tavolo della cucina, strappandogli la maglietta a morsi. Gaudì gli tira giù i pantaloni e inizia a segarlo coi piedi. Con un rantolo Diocleziano si lascia cadere all’indietro, rimanendo in piedi solo perché appeso per la nerchia agli alluci di Gaudì.
Ma poi non voi due, ingroppatevi me, ME, implora Mariella, agitando vanamente il blocco note con i suoi appunti.
Niente. Gaudì riporta Diocleziano verso di sé. Il Maciste gli cade addosso. Gaudì scivola in basso, e opponendo al mostruoso bischero una voragine di mandibole, glielo fa sparire in gola. Dopo un po’ Diocleziano non ne può più: butta tutto quello che possiede dentro i recessi di Gaudì, che si mette a pecora ed è generosamente fottuto.
Mariella Menchelli, asciugandosi una lacrima, ordina alla regia un piatto di spaghetti alla puttanesca e infine se lo sbafa, appollaiata sul suo trespolo, prima di dare la linea al telegiornale.
*
Per una ricetta degna dell’amore focoso di Gaudì e Diocleziano, vi serviranno (4 persone):
- 350 gr. di spaghetti
- 2 o 3 acciughe (si possono omettere se non le gradite)
- Aglio, prezzemolo e olio a piacere
- 700 gr. di pomodori pelati/passata di pomodoro/pomodorini in conserva
- 15 gr. di capperi sotto sale
- 100 gr. di olive di Gaeta (o quelle che avete, basta che siano denocciolate)
- Peperocino q.b.
Per la preparazione del sugo, schiaffate peperoncino, aglio, capperi, olive e acciughe tritati nell’olio di una padella. Fate andare per qualche minuto, poi versate i pomodori o la passata. Lasciate cuocere una mezzoretta, giusto il tempo che i vostri amici e/o parenti si ricompongano (nel caso fossero presi dalla passione di cui sopra). Mettete a bollire l’acqua della pasta e cuocete gli spaghetti. Quando saranno indietro di due minuti, scolate e versate la pasta nel sugo, poi finite la cottura con un po’ d’acqua calda. Impiattate, via di prezzemolo e buona “puttanesca” nella vita e nell’amore a tutti.
PS: Nel remoto caso avanzino, potete replicare il gioco di D’Orvilliers e Almiraghi. Vi serviranno solo delle demoiselles e una buona donna delle pulizie.