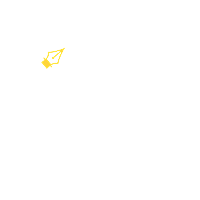Al di là del vetro
“Warren ha tirato fuori una foto piegata dalla tasca dei calzoni di tela.
Era una veduta aerea di una piccola isola. L’isola era a forma di cuore”.
Rientrata, Amy Hempel
La linea ferroviaria era un cimitero pieno di ruderi. Le rovine della torretta erano ancora lì, in mezzo ai campi coltivati tra Montallese e Fasciano. Il tetto divelto, la postura compromessa dall’usura e dal tempo. A Marco quel tripudio di decadenza aveva sempre fatto riflettere, e, in qualche modo, lo affascinava.
«Passeggeri saliti a Roma?»
Marco annuì. L’uomo in divisa gli porse una scatola di colore rosso e una boccetta d’acqua naturale da 25 cl, dopodiché proseguì dritto trainando con sé il carrello. Marco lo osservò mentre serviva una famiglia di cinque persone con un forte accento spagnolo; ne esaminò le scarpe, il cavallo dei pantaloni ammucchiato sul dietro, la forfora sul colletto della giacca, le tempie imperlate di sudore. Immaginò la sua sveglia che suonava e lui che in preda allo sconforto si incamminava verso il bagno grugnendo; poi, l’atto del vestirsi, il tragitto verso la stazione, e, infine: «Passeggeri saliti a Roma?». Lo ipotizzò genitore, o forse no, forse viveva ancora con i suoi. Marco distolse lo sguardo e tornò a concentrarsi sul finestrino.
Il rosso pompeiano delle vecchie case cantoniere appariva ormai sbiadito, ma ciò che più di ogni cosa lo emozionava era la presenza di abitazioni lungo i binari. Tra tutte, quella torretta era la sua preferita, non sapeva spiegare il perché. A chi apparteneva? Che vita facevano i suoi proprietari? Chissà chi ci aveva dormito e se erano ancora vivi. Come un naufrago guardando il mare vedeva scorrere tra le onde la sua intera vita, così era per Marco attraverso quel vetro. Il viaggio per lui rappresentava la culla del pendolarismo dei suoi ricordi. Un’altalena in grado di spingerlo avanti e indietro tra Roma e Firenze pur mantenendolo ancorato lì, immobile, a rimuginare sul suo passato ricco di aspettative fallite. Nei periodi peggiori dovuti all’instabilità del suo rapporto con Lisa, quell’attesa non faceva che amplificarne lo stress. Una volta era riuscito a bere sei caffè in un’ora, generando lo stupore dell’addetto al bancone. «Sia chiaro, a me il caffè piace» aveva detto, «ma lei mi batte e di tanto pure». Era il giorno in cui Lisa aveva espresso la sua volontà di andarsene di casa, per poi, due settimane più tardi, presentarsi alla porta con due pizze e due supplì dicendo che lo amava.
Marco estrasse uno dei due biscotti dalla scatola rossa. Lo scartò e lo masticò. Era buono, sapeva di cannella. Fece un calcolo rapido delle ore che era solito trascorrere al posto 15D della carrozza 3 nell’arco di una settimana: quasi un giorno su sette, in pratica quel sedile aveva impressa l’immagine del suo culo. Un rifugio accogliente, dove incubare i malanni ed esaminare l’andamento della sua vita. Un esempio di clausura che lui ben sopportava, al contrario di quei passeggeri che, tra il ritardo e il latrato di un cane, trovavano il pretesto per sfogare le loro angosce; la necessità dello scontro e il bisogno di un capro espiatorio che a qualcuno sembrava per diritto incluso nel biglietto. A differenza di molti, quando il treno accumulava minuti, Marco era felice. Più la sosta cresceva, più tempo lui aveva per spiare il mondo al di là del vetro. Un mondo, di questo ne era certo, che neppure il miglior film distopico con macchine volanti e corsie interstellari sarebbe stato in grado di riprodurre. Una volta, all’ingresso del nodo di Genova, dove il treno procedeva a marcia ridotta per via delle gallerie più simili a montagne russe, aveva intravisto una coppia sulla quarantina mentre faceva l’amore con le finestre aperte per colpa del caldo torrido – il sorriso sincero di lei, le chiappe bianche di lui –; un’altra volta, invece, un uomo in piedi di fronte allo specchio in procinto di radersi le palle. Fosse stato per Marco, mai gli sarebbe saltato in mente di acquistare un podere o una casa nei pressi della ferrovia; era certo che la vita non gli sarebbe più appartenuta, divenendo in un attimo di dominio pubblico. Non che quella in cui viveva gli appartenesse per davvero, nonostante da dodici anni pagasse un mutuo. Spesso sbirciava fuori e immaginava di sorvolare le città, accedendo senza permesso alle case degli altri. Quadri mastodontici, lampadari d’antiquariato, ma anche muri scrostati e cucine in rovina. Cosa avrebbe pensato una qualunque persona vedendo lui e Lisa sputarsi addosso cattiverie e veleni? Li avrebbe derisi oppure compatiti? La verità – da parecchio tempo ormai credeva di averlo capito – era che a lui quel rito del viaggio serviva tanto quanto a chi, di settimana in settimana, andava all’incontro col suo terapeuta. Per Marco si trattava di un reset encefalico, in grado di riassestare vita privata e vita professionale; un’isola errante, come quella descritta nel manga di Tsuruta, dove lui però non ricopriva il ruolo di un affascinante postino dei cieli, bensì di mero contabile di un’azienda che da anni dimenticava di valorizzarlo.
Bevve un sorso d’acqua e si adagiò sul poggiatesta. La voce registrata di una donna informava i passeggeri del sistema antincendio pronto a scattare nel caso in cui qualcuno avesse trasgredito il divieto di fumo. Marco ripensò a quella volta in cui, vent’anni addietro, lui e i suoi compagni di liceo avevano causato l’azionamento degli sprinkler nella loro camera d’albergo di Berlino dopo aver finito un pacchetto intero di sigarette tedesche al gusto di sigaro Toscano. Gli sembrava ancora di udire le grida della Prof.ssa Zanzi, che sul corridoio invocava in ciabatte la loro sospensione una volta tornati a casa. Marco ammiccò un sorriso. Quel ricordo gli parve lontanissimo, eppure così nitido che il pensiero del tempo trascorso lo sconcertò. Era questa la sua debolezza, il difetto che Lisa tanto gli additava: mentre lei puntava dritta al presente, cercando di convertirlo al meglio in futuro, lui perdeva tempo appresso al tempo, impedendo alla coppia di progredire. Aveva detto proprio così: «progredire». Conoscendola come soltanto lui poteva, il significato profondo di quella parola gli era stato chiaro fin da subito: diventare madre, avere una famiglia. Lisa non glielo aveva mai tenuto nascosto, eppure in quel momento Marco rimuginava ancora sulle grida della Zanzi e su Giorgio, Simone e lui chiusi a chiave nel bagno a ridere come matti. “Vent’anni” pensò, aprendo l’altro biscotto che si rivelò insapore.
Sollevò la testa e guardò il display. Il treno viaggiava in perfetto orario, trenta minuti lo separavano dalla sua monotonia casalinga. Si alzò e si incamminò verso la vettura ristoro. Al banco ordinò un caffè per contrastare la sonnolenza postprandiale che lo stava invadendo. L’addetta ripeté a voce alta la sua richiesta e iniziò a maneggiare il braccio, dopodiché azionò il pulsante e si passò una mano sulla fronte.
«È dura oggi?»
«Oggi, domani, e dopodomani» rispose lei, senza distogliere lo sguardo dal led verde della macchinetta. Una volta spento, gli consegnò il bicchierino fumante.
«Lei scende alla prossima?»
Marco annuì, bagnandosi le labbra col caffè. L’addetta fece lo stesso. Dai suoi occhi trapelava un sentimento di invidia che Marco non poté fare a meno di notare; pensò di confidarsi con lei, dirle che avrebbe fatto volentieri a cambio: lui sul treno a fare i caffè, lei con Lisa tra quelle quattro mura della periferia est di Roma, dove, nell’arco di un mese, i ladri avevano rubato in cantina per ben quattro volte. Lui, un isolano transumante con la possibilità di guardare sempre al di là del vetro, mentre lei sarebbe stata prigioniera nel suo condominio.
Marco pagò con la carta e rimase in attesa a fissarla.
«Ognuno ha la sua prigione» disse a un tratto la donna, quasi leggendogli nella mente. «Spero che la sua sia meno claustrofobica, ma soprattutto con molti meno cafoni attorno. Ecco a lei, buona giornata.»
Marco afferrò lo scontrino, ricambiò il saluto, e si allontanò a rilento. Una folata piacevole di aria condizionata lo accolse di nuovo in carrozza 3. Frattanto che planava di peso sul sedile, le parole dell’addetta alla ristorazione gli riecheggiarono nella testa. “Ognuno ha la sua prigione”, si ripeté.
Scrutò il vetro e pensò che la linea ferroviaria era un cimitero pieno di ruderi. Onde ferrose su cui navigavano isole erranti ricolme di anime tristi.
~
A illustrare: fotografia di Henri Cartier Bresson, “Quai St.Bernard”, Parigi, 1932.