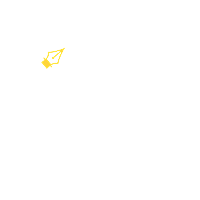Caro Disastro
Fu in quell’istante, mentre guadagnavamo la costa, allontanandoci dalla nave che barriva come un pachiderma morente, che urlai al signor Gucci che non l’avrei fatto più.
Lui mi fissò tra gli schizzi salati, mantenendo saldo il suo sguardo nel mio nonostante il rollio dell’imbarcazione, e io glielo ripetei: mai più! Così, in faccia.
Mi lanciò un’occhiata di compassione, che si trasformò in rabbia subito dopo. Pensavo fossi fatto di un’altra pasta, ringhiò.
I pianti delle vittime, le grida dei soccorritori, il dolore delle persone: era un fardello troppo pesante per me.
Lui rimase in silenzio qualche istante, mentre rallentavamo per accostare alla banchina. Poi avvicinò le sue labbra al mio orecchio.
Non provare a cercarmi o me la prenderò con tua madre, mormorò.
Riesco a ricostruire con precisione la prima volta che incontrai il signor Gucci.
Ero certamente a Viareggio ed era certamente l’inizio di luglio del 2009, perché era trascorso pochissimo tempo dal giorno del disastro ferroviario, forse una settimana.
All’epoca bazzicavo il sottobosco del giornalismo di provincia come fotografo di nera. Ero un giovane freelance ancora colmo d’entusiasmo, ma con pochi spiccioli in tasca.
Volevo approfittare dell’allentamento delle maglie dei controlli per scattare qualche foto nella zona più colpita dalla sciagura: se avessi immortalato qualche scorcio inedito o qualche particolare interessante, per quella che era ancora la notizia del momento, forse sarei riuscito a veder pubblicato un mio scatto persino su una qualche testata nazionale. All’epoca ero molto sprovveduto.
Gironzolavo attorno alla zona off-limits dell’incidente. Sapevo che dopo il deragliamento del treno merci, le cisterne si erano squarciate e avevano riversato il loro contenuto, del gas propano liquido, nel quartiere a ridosso della ferrovia, soprattutto verso via Ponchielli. È lì che le esplosioni avevano causato maggiori danni e soprattutto maggiori vittime.
Tuttavia in quella zona il cordone di carabinieri e vigili del fuoco era ancora rigido e non lasciava passare nessuno senza autorizzazione.
Ero bloccato e senza idee.
Proprio quando stavo per tornarmene a casa senza aver scattato neanche una foto, notai qualcuno che provava ad attirare la mia attenzione.
Era il signor Gucci, che all’epoca non conoscevo. In gilet arancione catarifrangente, l’uomo, uno smilzo signorotto con naso aquilino e pizzetto demoniaco, mi apostrofò con un “tu, fotografo” e mi fece segno di avvicinarmi a lui.
Mi chiese con tono ironico se sapessi usare l’aggeggio che portavo appeso al collo e se ero disposto a fare delle foto per suo conto. Dietro di lui due uomini e una donna, anche loro in gilet arancione, sembravano molto interessati alla nostra conversazione.
Risposi che ero a sua disposizione, se mi avesse concesso l’autorizzazione a superare lo sbarramento di agenti che regolamentava gli ingressi alla zona del disastro.
Lui mi rispose con un cenno della testa e mi invitò a unirmi al gruppo.
Non si presentò, né mi presentò le persone che erano con lui. Si limitò a passarmi un gilet arancione e a intimarmi di non proferire parola: avrebbe parlato soltanto lui.
Ci dirigemmo per via Porta Pietrasanta verso una pattuglia dei carabinieri che sbarrava l’accesso. Si avvicinò da solo, ordinandoci di rimanere a distanza, e iniziò a parlare con il militare che sembrava il più alto in grado.
A quella distanza non riuscivamo a capire cosa si stessero dicendo, ma non avemmo il tempo di provare a origliare: pochi minuti e fummo invitati ad avvicinarci dallo stesso signor Gucci. Il maresciallo ci avvisò di seguire i percorsi segnati col nastro segnaletico bianco-rosso, di non disperderci, di non entrare nelle abitazioni e che io sarei stato l’unico a poter scattare fotografie. Ci requisirono i cellulari e ci diedero un quarto d’ora di tempo per esaminare la scena dell’incidente.
Ci addentrammo in gruppo, mentre il signor Gucci mi sussurrava di scattare a raffica, più che potevo.
Eseguii i suoi ordini, mentre l’odore acre di bruciato si infilava nelle narici. Immortalai finestre annerite dal fumo, scheletri neri di alberi, muri diroccati, binari divelti, carcasse di automobili e, in lontananza, le cisterne rovesciate o quello che ne rimaneva.
I minuti passarono rapidamente e in un attimo il signor Gucci ci chiamò a raccolta invitandoci a percorrere a ritroso il tragitto e tornare dai carabinieri, i quali ci restituirono i cellulari e ci lasciarono andar via.
Solo dopo aver percorso qualche centinaio di metri, ci sfilammo i gilet e riprendemmo a respirare normalmente.
Eravamo tutti molto scossi. Sapevo delle vittime e mi dispiaceva speculare sulla vita delle persone. Il senso di colpa era opprimente.
Il signor Gucci mi si avvicinò e mi chiese la scheda di memoria della macchina fotografica. Nel farlo, gli comparirono in mano delle banconote da 100 euro, come in un ruffiano gioco di prestigio. Me le porse. Non fiatai e gli passai la schedina. Quella cifra era più di quanto avessi mai guadagnato fino a quel momento. Mi passò anche un biglietto da visita, col quale scoprii che organizzava tour turistici. Mi ringraziò di aver collaborato con lui.
Ci salutammo con una stretta di mano e scomparì dalla mia vista, insieme alle altre tre persone.
Passarono un po’ di settimane nelle quali provai a telefonare più volte al numero sul biglietto da visita, per chiedere al signor Gucci se avesse qualche lavoretto adatto a me, ma il numero risultava sempre non raggiungibile.
Smisi di provare e di pensarci fino al febbraio successivo.
Ero al bar a prendere un caffè insieme a un amico giornalista che mi stava promettendo dei lavori fotografici per un giornale distribuito gratuitamente nei negozi della zona, mentre nel televisore appeso alla parete di fronte passavano le immagini del telegiornale.
Il servizio di apertura era dedicato al disastro ambientale del fiume Lambro, nelle cui acque, in una delle notti precedenti, era stata riversata un’ingente quantità di petrolio.
Gli idrocarburi erano stati trasportati dalla corrente avvelenando ogni forma vivente incontrata lungo il percorso.
Le immagini del telegiornale mostravano i vigili del fuoco, i volontari della Protezione Civile e quelli del WWF impegnati a installare dighe galleggianti per contenere la colata, a recuperare i cadaveri degli animali dalle acque e ad aiutare quelli imbrattati di olio nero.
Poi, sul greto del fiume, in secondo piano nascosto dagli arbusti, intravidi un piccolo gruppo di osservatori. Adocchiai l’uomo che guidava il capannello di persone: era il signor Gucci. Proprio lui, in tuta da lavoro e caschetto protettivo.
Recuperai il cellulare dalla tasca, zittii il mio amico, che stava commentando di quanto l’essere umano fosse menefreghista nei confronti dell’ambiente, e chiamai il signor Gucci.
Questa volta dava libero.
Squillò a lungo, almeno una quindicina di volte; infine, scattò la segreteria telefonica. Gli lasciai un messaggio balbettante, in cui mi presentavo, perché non ero sicuro che si ricordasse di me, e gli domandavo se avesse bisogno di un bravo fotografo.
Ripresi fiato e finii il caffè, mentre il mio amico riprendeva a blaterare.
Fu il signor Gucci a richiamarmi, ma lo fece con i suoi tempi.
Era l’inizio del 2011 quando mi giunse la sua telefonata. Riconobbi il numero, che avevo memorizzato come “signor G.”, e risposi subito, sebbene stessi cenando con mia madre.
Era in città, nella mia città. In verità non mi chiesi come facesse a sapere dove abitassi. Non ricordo di averglielo mai detto. Forse aveva fatto delle ricerche su di me. Mi invitò in un noto locale del centro per mangiare un boccone e per parlare di affari.
Non me lo feci ripetere due volte. Salutai mia madre, lasciando il piatto di maccheroni ancora fumante sul tavolo, e infilai il cappotto. Lei mi accompagnò alla porta rimproverandomi di non essermi scelto un lavoro tranquillo e raccomandandomi di coprirmi e di fare piano.
La vineria che aveva scelto era affollata, non sapevo se avesse lasciato un nome all’ingresso, ma essendo amico dei proprietari non mi fu difficile entrare. Dovetti girarmi tutte le stanze prima di trovarlo in un angolo, nel tavolo più riservato al secondo piano.
Non era cambiato per niente, in questo anno e mezzo. Non un capello bianco, non una ruga in più.
Mi accomodai e mi fece subito sentire a mio agio. Aveva ordinato una bottiglia di Brunello di Montalcino e un tagliere di salumi prelibati: il meglio che la Toscana potesse offrire in campo enogastronomico.
Arrivarono pochi istanti dopo e prendemmo subito a riempirci i piatti, mentre lui mi chiedeva se avessi capito il lavoro che faceva.
Risposi che organizzava escursioni turistiche non ordinarie.
Lui mise in bocca una fetta di finocchiona e, senza aspettare di ingoiare, aggiunse che la sua agenzia copriva una nicchia di mercato che le altre agenzie ignoravano. Lo affermò con una certa dose di compiacimento.
Ingoiò e prese un sorso di rosso. Poi continuò: la sua agenzia non aveva concorrenti perché nessuno inquadrava i cataclismi e le tragedie come delle forme di attrazione turistica, anche se lo sono da sempre.
Fece una pausa prima di entrare nello specifico. Portò come esempio quanto fosse difficile mantenere gli occhi sulla strada quando si passa accanto a un incidente d’auto, o quanto fosse difficile non soffermarsi sullo spettacolo di una carcassa in decomposizione di un animale morto trovata per caso durante una passeggiata nel bosco. Impiegò proprio quella parola: “spettacolo”. Concluse riportando che nel 2004 la decapitazione in Iraq dell’ostaggio britannico Ken Bigley determinò un’impennata di ricerche in Google senza precedenti. Quindi sorrise e imboccò un pezzo di lardo di colonnata spalmato su un crostino dorato.
Annuii. La sua agenzia, continuò, doveva stare sempre all’erta, non si poteva prevedere dove sarebbe accaduta una nuova sciagura, e soprattutto di che tipo sarebbe stata.
Era un’attività che richiedeva prontezza e totale flessibilità. Per questo aveva bisogno di un gruppo di amici, sparsi per la penisola, che lo aiutassero in tutta una serie di incombenze pratiche.
Annuii di nuovo. Immaginai che le mie competenze nel campo della fotografia potessero essergli molto utili.
Si pulì gli angoli della bocca con il tovagliolo e mi chiese se fossi interessato a fare da referente per il centro Italia: Toscana, Umbria, Lazio.
Sorrisi. Lui ricambiò il sorriso. Aggiunse che i guadagni erano la cosa più bella di quell’impresa.
Il cellulare squillò e io spalancai gli occhi all’istante.
Era il signor Gucci. In piena notte.
Da quel giorno in vineria, più o meno un anno prima, non ci eravamo più visti, né sentiti.
Io me ne ero fatto una ragione e avevo iniziato a collaborare con la pubblicazione del mio amico giornalista, che si era rivelato nient’altro che un giornalaccio, poco più che un volantino promozionale, interessato solo alla pubblicità. Però almeno riuscivo a pagare le bollette e mettermi da parte qualche soldo.
Il signor Gucci invece mi aveva ingiunto di non chiamarlo: si sarebbe fatto vivo lui al momento giusto.
Io avevo eseguito.
Risposi al telefono con la bocca cementata dal sonno e dal digestivo che avevo bevuto la sera prima.
Mi disse di prepararmi velocemente. Nel giro di un’ora mi sarebbe passato a prendere un suo amico, un collaboratore dell’agenzia, a cui aveva mandato il mio indirizzo di casa. Era di strada. Preparai la macchina fotografica, mi vestii e infilai il cappotto. Scesi in strada nonostante fosse gennaio e si ghiacciasse. Volevo recuperare più tempo possibile.
L’amico arrivò rombando, un po’ in anticipo rispetto al previsto. Neanche il tempo di salire e sgommò in direzione sud.
Mi riferì che il signor Gucci ci stava aspettando con tre clienti vicino Grosseto. Era la prima volta che si menzionavano esplicitamente dei “clienti”.
Viaggiammo quasi due ore col gas sempre a manetta su strade buie e deserte.
Non sapevo se essere più preoccupato per lavelocità a cui viaggiavamo o per lapossibilità di un colpo di sonno dell’autista. Provai ad attaccare bottone con l’amico di Gucci, ma era un tipo taciturno: non riuscii a scucirgli quasi niente. Niente nome, niente provenienza. Mi raccontò soltanto che l’inizio della collaborazione col signor Gucci risaliva al 1991, quando lui era poco più che ventenne, in occasione dell’incidente del Moby Prince. Scoprii anche che lui era il referente della Liguria e stava scendendo perché c’era bisogno delle sue competenze tecniche.
Attraversammo la notte come un sottomarino silenzioso solca le profondità dell’oceano e giungemmo finalmente al punto d’incontro, ma non ci fu il tempo di salutarci.
Il signor Gucci, rilasciando nuvolette di fiato dalla bocca, asserì che saremmo arrivati sul luogo prestabilito all’alba, in tempo per lo spettacolo più bello. Lo aveva fatto di nuovo. Aveva usato di nuovo la parola “spettacolo”.
I tre che erano con lui gongolarono.
L’amico del signor Gucci lasciò l’auto in uno spiazzo e proseguimmo tutti e sei col furgoncino.
Viaggiammo nel buio per un’altra quarantina di minuti fino alla costa, tagliando per l’Oasi naturale di Orbetello.
Scendemmo verso il porticciolo di Porto Santo Stefano. Ci aspettavano due tizi infagottati, che parlottarono col signor Gucci e con il suo amico ligure, mentre noialtri attendevamo nel furgone.
Alla fine scendemmo tutti e ci fu indicata l’imbarcazione sulla quale avremmo dovuto salire. La brezza che arrivava dal mare ci tagliava la faccia, ma non era così terribile, per essere gennaio.
Ci muovemmo in fretta, il sole stava per sorgere e non potevamo mancare l’attimo.
Sopra le nostre teste sentivamo gli elicotteri che andavano e tornavano.
L’amico ligure dimostrò le sue competenze mettendosi alla guida dell’imbarcazione a motore, salpando velocemente e prendendo subito una buona velocità tra i flutti, mentre il signor Gucci mi si accostava per istruirmi, urlando sopra il rombo del motore e lo sciabordio delle onde: tante fotografie, con mare e sole nascente, e anche dei piccoli filmati.
Gli chiesi quale fosse la nostra destinazione.
Isola del Giglio, mi rispose.
A illustrare il racconto una rielaborazione grafica della locandina de L’avvocato del Diavolo