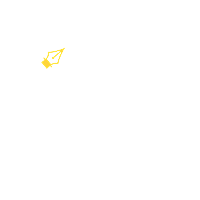Tornare a guardare le luci
Riesco ad aprire la porta soltanto al secondo tentativo. Mi viene ancora da girare la chiave verso sinistra, come facevamo nella vecchia casa, quando tornavamo con mille buste della spesa in mano e dovevamo fare i giochi di prestigio per non far cadere tutto. Questi pochi mesi non sono bastati a spazzare via cinque anni di abitudini.
Il pulsante è verso sinistra, vicino all’appendiabiti, anziché a destra: accendo la luce in corridoio e vado in bagno. Lavo le mani due volte, con cura. Dopo essere certa di aver fatto le cose per bene, appendo la mascherina sul mobiletto, accanto a spazzolino e dentifricio. Anche quella mi ricorda che abito un mondo diverso da ieri. Un mondo inconcepibile. Solo i rumori delle macchine in strada mi suggeriscono che stiamo scivolando con lentezza verso una nuova normalità.
È che per mesi ho vissuto il nulla. La strada si stagliava lunghissima e nuda oltre le finestre: tutto intorno quella vacuità irreale era interrotta solo dagli applausi e dai cori disperati che scandivano le giornate infinite. Di notte, nel letto enorme sembrava infrangersi un silenzio che non credevo possibile. Non qui, non a Roma.
Torno all’ingresso a prendere il libro e lo porto in cucina. La copertina è bellissima, anche se forse il bianco e nero non è granché adatto. La sua è una scrittura colorata, accesa. Si sedimenta come l’acqua che si infila fra gli scogli creando quelle pozze dove ristagnano conchiglie e mozziconi di sigarette.
Alzo lo sguardo verso la finestra, sui cui vetri si staglia il mio riflesso, e mi sento una stupida a stare qui in piedi, immobile, col sorriso sulle labbra e la tristezza negli occhi, a usare immagini poetiche per parlare di lei – ancora di lei – dopo tutto questo tempo. Passo le dita sul suo nome in rilievo. Elisa Baccano: gliel’ho sempre detto che aveva un nome fatto apposta per stare là sopra.
Esco sul terrazzo. L’altra sera abbiamo lasciato le bottiglie di rosso sul tavolo, accanto al posacenere. Un filtro bianco, uno giallo, un altro fatto col biglietto dell’Atac. Dovrei gettare via tutto e fare ordine, ma di recente persino questi scarti insignificanti hanno assunto una loro bellezza.
Senza i fuorisede, migrati altrove come uccelli, i palazzi paiono giganti addormentati. Allungo i piedi sul tavolo. Prendo un respiro, sfoglio le prime pagine, resto delusa.
Chissà che m’aspettavo. Forse di leggere il mio nome sul foglio. Avevamo spesso scherzato su quella cosa: Non crederebbero mai che sia una vera dedica, diceva; penserebbero che sto citando Leopardi. Le dicevo che bastava aggiungere un aggettivo: alla mia Silvia. Chissà se sei veramente mia, sentenziava lei. Allora fingevo di arrabbiarmi, incrociavo le braccia e le mostravo il medio. Era suo compito, a quel punto, trovare un modo per entrare dentro di me, sebbene ci fossero giorni in cui riuscirci era faticoso: a volte mi sussurrava dei versi carezzandomi la guancia, altre mi prendeva di peso e mi sbatteva contro il frigorifero, facendo cascare tutte le calamite. Io lo sentivo subito, il calore in mezzo alle gambe, quel fiume in piena che solo lei sapeva alimentare. Non cedevo subito però, perché l’amore in quei giorni aveva il sapore di una piccola guerra: sentivamo il bisogno di uscirne a pezzi, sfinite. Oggi che negli sguardi di un’altra cerco solo pace, riposo dopo giornate sfiancanti, mi chiedo perché abbiamo sprecato tutte quelle energie a lottare e a massacrarci, invece di mettere da parte per quell’inverno che sarebbe arrivato.
Ma quella dedica non è per me. Quelle tre parole, quelle nove lettere, parlano di una famiglia declinata al femminile: di una donna fragile inadatta alla vita e di due ruoli che non avrebbero mai dovuto invertirsi, perché una figlia non dovrebbe essere madre della propria madre.
Era invecchiata di cent’anni, alla fine. La aspettavo fuori dal negozio: la osservavo chiudere cassa, spegnere le luci e abbassare la saracinesca – lo faceva con gesti lenti, faticosi, come se dovesse tenere su di sé le sorti di tutti – e poi, senza dire più di due parole, montava in macchina e si addormentava all’istante. Si svegliava di botto, guardandosi intorno spaesata, quando arrivavamo all’ingresso dell’ospedale. Il viaggio fra i reparti trascorreva in un silenzio religioso. A volte entravo nella stanza con lei, tenendole la mano di nascosto; di solito però restavo fuori, e quell’ora passava così, a scorrere Instagram o a scrivere su Wapa. L’avevo scaricata per gioco, quell’app, per affrontare la noia. A ripensarci, a guardarmi indietro, mi pervade la vergogna: mentre la madre della ragazza che dicevo di amare stava morendo senza neanche sapere di avere la propria figlia accanto, io flirtavo con perfette sconosciute per nobilitare la mia vita banale con un po’ di tragedia.
Era solo un gioco: gliel’ho ripetuto non so quante volte, dopo. Glielo urlavo, e aggiungevo che non avrebbe dovuto permettersi di controllarmi il telefono. Ma come nel più banale dei copioni, ero diventata uno di quei serial killer che lasciano in giro delle tracce per farsi scoprire: una notifica qua, un messaggio là. La sera, lei provava a leggere un libro accanto a me – gli occhi scavati da un pianto che non mi consentiva di vedere, come se non si fidasse di mostrarsi vulnerabile – e io chattavo. Ingannavo me, lei, e anche quelle perfette sconosciute: inventavo impegni per rimandare i loro inviti e un letto freddo in cui farle entrare solo per gioco, senza immaginare la potenza di quel vecchio adagio sullo stare attenti a ciò che si desidera.
I lampioni s’accendono di botto. La sera è scesa senza che me ne accorgessi.
Mi sporgo per osservare il fiume di macchine che riempie la Tiburtina. Ho sempre vissuto al primo piano e ora, da questo terrazzo, tutto è minuscolo e distante. Da qui posso vedere il bar dove ho lavorato per una vita: Marco ogni tanto esce, il grembiule nero macchiato di crema o caffè, in bocca una sigaretta. A volte alza lo sguardo come colpito da un’intuizione. Ci salutiamo, poi con la mano gli dico che più tardi passerò.
In lontananza, al di là della strada intasata, vedo il nostro vecchio appartamento. Chissà chi ci vive, oggi, lì. Chissà se anche loro sono come noi siamo state: se una di loro è una studentessa di economia che mollerà tutto a cinque esami dalla laurea e l’altra si ritrova di notte a scrivere pezzi di canzoni su un quadernetto che si porta appresso dal liceo. Chissà se riescono a pagare le bollette, se si baciano di nascosto come facevamo noi, se condividono i nostri stessi sogni assurdi.
Non so niente di chi abita lì. Però so che quando escono sul loro minuscolo balcone, che a malapena può contenere un paio di piantine, si trovano davanti lo stesso mostro di vetro che opprimeva noi due.
E ora che il sole è tramontato, le luci della Bnl tornano a risplendere sulla ferrovia, sul cielo ingombro di nuvole, sulle nostre vite indecifrabili.
Mai e poi mai avrei immaginato di sentire la loro mancanza. Passavamo notti intere a guardarle, io ed Elisa; a sperare di andar via per non vederle mai più.
Torno dunque a sfogliare delle pagine che non fanno più paura.
Le lettere nere raccontano la sua storia. Quelle luci gialle laggiù, invece, la mia.
Foto e illustrazione di Chiara Tescione