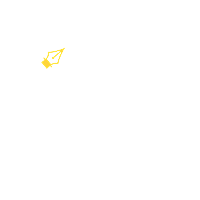Buono come il pane
La prima volta che si presentò un’opportunità Miriam la colse.
L’imbianchino, stufo di tinteggiare stanze su stanze, aveva piantato in asso secchi di vernice e pennelli imbevuti di colore. Se n’era andato all’osteria a ritemprarsi dalle ultime fatiche, chissà quando si sarebbe rivisto. Soprattutto, aveva lasciato incustodita la scala.
Suo padre era in sinagoga, sarebbe rientrato per cena. La nonna voleva comprare malto d’orzo e semi di papavero per i bagel, disse che andava festeggiata la fine ormai vicina dei lavori. In verità fremeva sempre per procurarsi uno sproposito di farina, malto, semi: le sue lunghe liste erano la gioia dei bottegai dei dintorni.
Nonna le raccomandò di stare buona e non aprire a nessuno, poi la lasciò da sola.
Miriam salì le scale, la passatoia ingoiava l’eco dei passi leggeri. Se non faccio rumore, non accadrà nulla, come quando si pensa. I pensieri non fanno rumore. Tutto questo non sta succedendo veramente, si ripeteva. In camera di Nonna, una stanza linda con bei mobili in noce scuro, la cassettiera proibita giaceva solida, indifferente. Lo specchio dall’argentatura rovinata, pieno di macchie scure che tempestavano la superficie come tigna, intristì Miriam. Si chiese perché mai il povero Kotec fosse dovuto morire mangiato vivo da quella orrenda malattia mentre lo specchio di Nonna, brutto com’era, venisse trattato da cimelio. Entrata nella stanza, distolse lo sguardo dalla propria immagine riflessa per non vedersi la faccia deturpata dalle macchie. Tirò dritta fino al mobile.
Imitò Nonna il giorno che l’aveva intravista trafficare nell’ultimo cassetto, sotto la biancheria di pregio utilizzata di rado. Miriam s’era prima lavata le mani per non lasciare traccia sui lini preziosi, ché si sporcavano solo a guardarli. Tuffò il piccolo pesce bianco del palmo fra le onde di stoffa e catturò il tesoro. Una chiave di ferro arrugginita. E ora, la scala. Non poteva strascinarla sul pavimento, il legno lucido si sarebbe rigato. Miriam, colta da un’insolita eccitazione, riuscì a sollevarla per i pochi metri occorrenti, posizionandola proprio dove le serviva. Alzò lo sguardo verso la botola ritagliata nel soffitto come un occhio indiscreto teso a scrutare l’intimità di quel luogo. Poi, una mano salda intorno alla chiave, l’altra poggiata sulla spalliera della scala per non perdere l’equilibrio, salì fino all’occhio e la infilò nella serratura.
La botola si aprì senza cigolii, senza opporre resistenza, senza incipriare Miriam in una nuvola di polvere. Si spalancò come il ponte levatoio di un castello stregato.
Facendo leva sulle ginocchia, Miriam si spinse a raggiungere il pavimento della soffitta. Facile come issarsi fino alla casa sull’albero costruita da papà a Reszel. Papà era così alto che per arrivare ai rami giusti doveva appena tendere le braccia avanti a sé.
Giunta in soffitta, la trovò sgombra e vasta come la sua delusione. Il parquet pulito, la luce del giorno che entrava dai lucernari e il pulviscolo dorato in una danza sospesa nel caldo soffocante. L’unica presenza a occupare spazio nel sottotetto era un vecchio lenzuolo, gettato in un angolo a coprire una catasta.
Tutte cianfrusaglie ammucchiate, da scommetterci. Miriam s’avvicinò e con aria annoiata scostò il lenzuolo.
Quando vide cosa c’era sotto, fece un salto indietro.
La creatura giaceva abbandonata su un cumulo di sacchi di juta, l’aria scomposta di un gigantesco burattino coi fili tagliati. Immobile, eppure Miriam ebbe pungente certezza di star di fronte a qualcuno o qualcosa che aspettava solo d’essere ridestato, proprio come nelle fiabe di Śpiąca królewna, che ha mangiato la mela avvelenata, oppure quella di Królewna Śnieżka, ferita dall’arcolaio magico. Erano le sue preferite.
Forse aveva trovato un principe da risvegliare con un bacio.
Non ci riuscì quella volta, né per molte altre in seguito. Il bacio non funzionò, nemmeno scuotere la creatura prendendola per le spalle giganti. Tantomeno farle boccacce, insultarla o accarezzarla.
Le lunghe pause forzate di riflessione tra una visita e l’altra Miriam le trascorreva lambiccandosi il cervello su nuovi tentativi di risveglio. Pizzicotti no, perché aveva paura di frantumarla brano a brano. Toccandola, le dita affondavano sottopelle. L’epidermide era crostosa e friabile, più sotto ancora si percepiva il turgore di muscoli sodi, d’una pienezza elastica. Nonostante la creatura restasse relegata senza lavarsi da chissà quanto tempo, sapeva di buono. C’erano, è vero, piccole ma disturbanti macchie sottopelle, come tanti semi scuri conficcati nel derma.
Forse la poca igiene? Un po’ le facevano impressione, come la tigna di Kotec o le macchie sullo specchio. Poi aveva superato la cosa. Quel suo profumo, così simile a quello dei bagel. La soffice consistenza dei panini dolci fatti in casa si era cementificata in muscoli, nervi e forza grezza conservando qualcosa di familiare.
Oltre al mistero dell’occupante in soffitta, c’era quello del buonumore di Nonna. Si chiese se avesse a che fare con la creatura. La casa splendeva, tutti i lavori venivano fatti alla svelta, e lei non appariva mai affaticata. Nonna non la sentivi mai lamentarsi di quanto tempo le rubasse tenere in ordine una casa così grande.
L’unica cosa su cui non transigeva era che non voleva nessuno tra i piedi durante le pulizie.
L’altro fatto che faceva scervellare Miriam era l’altezza sproporzionata di suo padre. In giro per casa non c’erano foto del Nonno. La Nonna però era piuttosto bassa. Eppure il padre era stato ribattezzato “Il rabbino più alto del mondo” dai suoi studenti del Kollel. Due metri e ventisei centimetri, dominava la comunità in tutti i sensi. Un gigante su cui poter contare.
Poter contare su qualcuno però non significa che sia propenso a dirti tutto ciò che vuoi sapere.
Gli unici a cui chiedere lumi erano i meno inclini a volerne dare. Miriam comprese che per infondere un alito di vita al cieco omone raggomitolato nel sottotetto doveva applicarsi. Se la Torah e gli altri libri sacri contenevano ogni risposta avrebbero saputo fornirle anche questa.
Il giorno in cui salì in soffitta conoscendo il nome e la storia di tutte le creature come lui, dei suoi fratelli, colossi d’argilla vissuti in un altro tempo e in altri luoghi, sentiva già che lo stratagemma avrebbe funzionato. Ma quale bacio: la chiave non era nelle labbra, bensì sulla fronte. Ormai lei era abbastanza grande da intuire quanto fosse importante riuscire a svegliarlo ma ancor più fermarlo al momento giusto.
Memorizzò la parola, poi cancellò dalla fronte della creatura la scritta מת e la sostituì con אמת.
La creatura s’animò d’improvviso. Miriam ormai aveva quasi tredici anni, era tardi per l’appuntamento con passatempi innocenti e futili, era presto per altro. Eppure, quando vide il Golem avanzare verso di lei e sovrastarla in tutta la sua imponenza, sentì un calore liquido infiammarle le cosce.
Avrebbe dovuto essere l’estremo tentativo, l’ultima prova. Invece fu il primo di molti altri incontri.
Era già sposata con Isaac quando tornò in Polonia per liquidare la casa di famiglia, dopo la morte del padre. Una giovane moglie affettuosa e fedele, del tutto a proprio agio nel ruolo di Signora Ha-Carmeili.
S’era ripromessa di sistemare la questione in poche settimane, tornare dall’Europa il prima possibile, riprendere la sua vita alla svelta. Corroborava la convinzione con il sazio scetticismo dell’età adulta.
Non aveva fatto i conti con la soffitta, doveva almeno un grazie al suo vecchio amico.
Dopotutto la nonna era morta nel suo letto, vegliata dal padre, parecchi anni più tardi rispetto ai piani che il Reich aveva avuto per la loro famiglia. Ad aprire la porta ai mitra spianati c’era stato Lui. Le pallottole si conficcavano nella massa del Golem per rimbalzare contro i nemici. A volte, paralizzati di meraviglia, i nazisti gli davano tempo d’uno scatto fulmineo e il Golem prendeva a spremere teste come acini d’uva maturi. A questo pensava Miriam quando tolse il lenzuolo. Lo trovò seduto là sotto, indifeso e scontento. Rigido come un enorme tozzo raffermo, le giunture ammuffite. Da troppo non veniva più riplasmato: la borsa nera in guerra, la vecchiaia dei suoi… Gli occhi restarono feriti, il cuore non volle sentire ragioni.
Primo amore, amico segreto…
«Kocham» gli sussurrò gentile, sfiorandone la fronte, cancellando anni in pochi gesti.
Il Golem annusò l’aria con fare torpido.
Accortosi di lei, esultò, la stessa animalesca esuberanza del cane che riaccoglie il padrone. Spontaneo come il bimbo che sgambetta felice se vede un viso noto affacciarsi alla culla.
Miriam si disse che non c’era nulla di male, sarebbe stata davvero l’ultima volta.
Dopo, l’avrebbe riaddormentato e distrutto per sempre.
Si amarono. Lui con l’ingordigia dell’attesa, lei con quella dell’addio.
Nacque Eddie. Miriam era felice, e con lei Isaac.
Quando il pancione spropositato si trasformò in un bambinone florido e forte, Tel Aviv le sembrò il posto più bello del mondo.
«Mazel tov» disse il rabbino. «Mazel tov» dissero tutti.
I primi mesi era così orgogliosa di come cresceva in fretta il suo Eddie! Gli aveva già perdonato la piccola prepotenza riservata ai fratelli. I medici tacitarono ogni suo cruccio. È la natura, signora, era destino così.
A Miriam avevano spiegato che all’inizio tre cuori le pulsavano in pancia, ma presto due battiti si erano spenti nel ventre. La sua gravidanza era stata simile a quel che succede nel nido scelto dal cuculo. Un uovo forestiero, più grosso degli altri, si schiude e spodesta quelli che la coppia ha concepito nella legittimità.
Quando partirono da Tel Aviv per gli Stati Uniti, Miriam scherzò sul fatto che suo figlio si fosse adattato subito a quel paese enorme, crescendo a dismisura anche lui.
Ogni giorno rafforzava la sua intima convinzione, ogni acquisto d’una taglia più grande, ogni volta che Eddie cambiava scarpette e quelle adoperate prima finivano smesse ancora come nuove.
Soffriva nel vedere Eddie disperato perché, nonostante fosse tanto buono e gentile, i giochi suoi e degli amici gli si rompevano in mano appena sfiorati. Quando svettava in mezzo ai coetanei ai giardini invece sorrideva compiaciuta. Che le importava della diversità, c’erano abituati, erano ebrei.
Nessuno l’avrebbe preso in giro apertamente, con un soffio poteva abbattere qualunque bullo.
Certo, la fame insaziabile era un problema per le loro tasche. Eddie non solo cresceva come tutti gli altri bambini del mondo, ma cresceva e cresceva e cresceva. Però erano felici così.
Quel figlio, molto prima del previsto e molto più del dovuto, li superò in altezza. Prometteva d’essere il bastone della loro vecchiaia. Torreggiando su chiunque s’era creato un varco nella vita, tutto da solo.
Non aveva trent’anni e già si esibiva nei locali, aveva un ruolo in uno spettacolo del circo, la gente faceva la fila per rimirarlo, nientemeno.
C’era stata persino una fotografa venuta da loro per un ritratto di famiglia. Proprio una bella foto. Diane, così si chiamava, che poi era una di loro, la figlia dei Nemerov, quelli dei grandi magazzini Russek’s.
Per essere una di nome era stata proprio gentile, aveva lasciato una copia dello scatto.
Quello che era piaciuto di più a Miriam era stata la tenerezza dello sguardo avuto per suo figlio.
La foto era finita addirittura pubblicata col titolo Jewish Giant, taken at Home with His Parents in the Bronx.
Sì, così lo chiamavano nel quartiere. Il gigante contento. Il gigante ebreo.
Il suo Eddie, proprio un ragazzo d’oro, non perdeva mai la pazienza, non c’era modo di contrariarlo.
A parte quando si insisteva per fargli assaggiare dei bagel. Non ne sopportava la vista, figuriamoci il sapore. La prima volta che aveva dato un morso a un bagel era rimasto schifato come chi assaggia un boccone di carne guasta.
Non c’era stato più verso di fargliene mangiare un pezzo, s’infuriava. Il carretto del venditore di ciambelle all’angolo se le ricordava ancora, le manate di Eddie.
A parte questo, cosa di poco conto ché ognuno ha le sue di idiosincrasie, nulla da dire.
Eddie era veramente un bravo ragazzo, un gigante buono. Buono come il pane.
«I really believe there are things nobody would see if I didn’t photograph them».
Diane Arbus