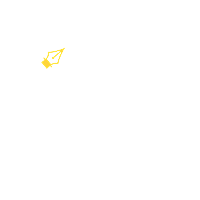Notte di Madreperla
La notte. La notte. Una volta, in periferia, ce n’era una per ogni piazzola. A ogni asola il proprio bottone.
«Aspettano il pullman» diceva papà.
Oscillavano distanti a pochi metri l’una dall’altra, come a non volersi toccare, alzavano il mento a mo’ di beninteso, con le braccia conserte, canticchiando una nenia straniera.
«Quando arriva il loro pullman, papà?»
«Dipende, hanno orari diversi.»
«Non hanno freddo?» mi preoccupavo io. Per la tramontana.
A volte, quando passavamo di lì in macchina, loro mi salutavano. Le loro bocche mi soffiavano baci pannosi, le vedevo anche al telegiornale.
«Guarda, guarda! Le signorine del marciapiede!» il dito puntato sullo schermo, ma papà cambiava canale.
A loro, alle ballerine luccicanti, quel vento tagliava le cosce aggrovigliate in reti nere: da lontano erano un intreccio di stringhe tirate quanto il filo spinato che il nonno attorcigliava intorno al pollaio. Anche se poi – la notte, la notte – la faina ci entrava lo stesso a dissanguare le galline.
La notte. La notte.
«Aspettano il pullman e basta» diceva ancora papà se gli facevo altre domande.
Io volevo vederle da vicino, quelle gambe da cavalla, ma lui andava al distributore di benzina sempre da solo, là, dove ce n’erano tre tutte insieme, di statuine affusolate. Quando andavamo a cena dalla nonna la domenica sera, poco prima della curva che seguiva il rettilineo, io mi preparavo mettendomi dritto dritto sul sedile; l’insegna blu del benzinaio era l’ombra di una medusa che si allargava sul parabrezza. I numeri del carburante cambiavano sempre, GA-SO-LI-O, LI-RE 1,097. Imparavo a leggere e a fare operazioni con i numeri, contavo il pallottoliere di ragazze sulla strada e sapevo che erano sempre loro, gli stessi capelli lunghi, la stessa postura, a volte le mani giunte. E la borsetta piccina doveva per forza essere magica, un portale da cui le cose entravano per non uscire più.
Tre brillantini che scivolavano via dai finestrini.
«Ma dove, io non ho visto niente» faceva mamma asciugando i vetri dalla condensa.
Ma sì, lo stesso costume da circense, lo stesso salto nel fuoco ogni sera, ogni sera un leone diverso. Anche le gonnelle aderenti, sgargianti, bandiere per gli automobilisti, come facevi a non vederle, mamma. Guardateci, ci siamo. Siamo qui, sembrava volessero urlare. Scandivano le ore della notte, le signorine gentili. Di mezz’ora in mezzora. Il tempo di un viaggio per fare rifornimento al benzinaio. Ogni tanto ci restavo male se non le trovavo, forse la corriera era già passata. Ciascuna all’ombra del proprio lampione, allacciate nella propria pelle lucida: pezzetti di vetro rotti lungo la via buia. Ognuna di loro, un frammento di.
La notte. La notte.
«Quando sono grande mi compro la moto e vado a vedere come sono fatte da vicino» dicevo al nonno.
Ma lui mi rispondeva con la storia delle lucciole che a fine stagione sparivano tutte. Io insistevo che non era vero, lui insisteva di sì. Ebbe ragione: dopo qualche mese non se ne videro quasi più. Forse si erano comprate una macchina. Ma dove andavano con il pullman? Dove andavano con la macchina?
Nonno cantava una canzone.
Quando più fitta l’oscurità
scende sulla città,
lucciole ansiose di libertà
noi lasciamo i bassifondi.
«Cosa vuol dire, nonno?»
«Cosa vuol dire, cosa vuol dire. Le lucciole, lo sai, sopravvivono poco, o finché qualcuno non le ficca in un barattolo e le tiene lì, piccoli lumi e fate sparse» diceva.
Le vedevo anche intrappolate in televisione, le mie signorine brillantinose, in quei film con il bollino rosso dove la gente si strusciava tutta nuda e mamma diceva “copriti gli occhi” prima che riuscisse ad afferrare il telecomando. Poi papà era morto, io e mamma ad aspettarlo a casa: il tempo di un viaggio per fare rifornimento al benzinaio. Non ci pensavo più a loro, alle trampoliere della notte.
La notte. La notte.
Qualche mese dopo il funerale mamma la incontrava per la prima volta, Serafina.
«Oh, Serafina. Accorri Serafina» piangeva in bagno, «Tu, tu dovevi!»
Usciva di lì con i pugni insanguinati, i capelli gocciolanti e una veletta di mascara che colava fino al mento. Mai ci riuscivo a strapparle quella ragnatela dalla faccia, ci provavo quando le chiedevo un abbraccio, ma il groviglio era ben appiccicato agli occhi, alla fronte, dentro la fronte. Mamma non tirava più lo sciacquone, parlava solo con Serafina. Al telefono e ovunque. Spariva pomeriggi interi nel campo dietro casa e parlava con Serafina, parlava con le nuvole gonfie di panna sdraiata nei cerchi di grano. Tornava all’ora di cena con gli occhi liquidi, parlava con Serafina.
«Mamma, perché Serafina non cena da noi?»
«Certo, amore. Certo che Serafina mangia con noi. Vero, Serafina?»
E allora preparava tutte le cose che a lei piacevano, cucinava ore e ore quelle sere. E io non potevo spiluccare nulla prima che lei avesse finito di impiattare le poche pietanze che non bruciava sul fondo della casseruola. Mangiavo cucchiai di pangrattato per zittire la fame, mi specchiavo nel cucchiaino umettato di bava facendo le smorfie. Il lavello era una discarica di pentolini e scarti di verdure, di orate sviscerate male, le loro squame di Madreperla.
Chi è Madreperla? Una perla che è più Madre della mia?
Giocavo a friggere gli avanzi delle teste dei pesci e i loro occhi nell’olio caldo, occhi cotti che non potevano piangere più. Mamma tirava fuori il servizio della dote, tutta la cristalleria apparecchiata sul tavolo con le tovaglie di fiandra.
«C’è sempre quel gatto che piscia sul rosmarino, vallo a cacciare» mi ordinava, per parlare in pace con Serafina delle cose che.
Ma io non lo vedevo il gatto, e poi come pisciava un gatto? Alzava la zampa come i cani o spruzzava in giro?
Mamma ogni tanto si teneva la pancia talmente rideva e masticava radici di liquirizia fino a sfibrarle: i lati della bocca si macchiavano con avanzi di saliva marrone che le allungavano il sorriso recitato, come una riga tratteggiata da ripassare a matita. Quelle linee che a scuola tracciavo sul quaderno d’italiano per fare bene le curve di una u, di una c. Quelle conchette in cui, se mi fossi fatto piccino piccino, mi ci sarei potuto infilare: una culletta, uno spicchio di luna, stare in una conchiglia. Invece stavo nelle n, nella speranza che la m di mamma non mi mozzasse la testa. Perché quando chiedevo “Dov’è Serafina?” lei si arrabbiava, mi lanciava la sedia, «Sono cose da dire a un’ospite che sta seduta di fronte a noi?»
E poi si incarogniva pure con lei, perché forse mi teneva le parti.
«Oh Serafina. Accorri Serafina!» la pregavo, allora.
Rubavo gli occhiali di nonno, quelli con le lenti spesse, ma Serafina era come Dio. C’era e non si vedeva. La vedeva solo mamma.
Quando litigavano, mamma le dava della puttana, sbraitava le bestemmie che avevo sentito dire al signore sporco di grasso che aggiustava le macchine. Chissà se Serafina lo conosceva, se c’era stata anche lei dove faceva il conto del lavoro, alle sue spalle il calendario della signorina del pullman con un collare nero. Il collare di un cane su una donna nuda. PLA-I-BO-I. Ridevo e pure l’amico di papà rideva. Tranne papà.
L’estate dopo che morì, mi feci una casetta nello sgabuzzino: era l’unico posto in cui non arrivavano le urla di mamma e il tanfo di vasetti finiti dei carciofini, delle scatolette di tonno, di quella crema di formaggio nel barattolo con l’etichetta blu che costava ventimila lire e di tutti i sacchi neri della spazzatura. Lo so, era compito mio andarli a buttare, io che ero l’ometto di casa, ma avevo paura del buio e dell’urlo della civetta.
Quando i nonni, dopo mesi, vennero finalmente da noi, si trovarono davanti una montagna di pattume in garage e dissero una parola strana tipo prodenti, predimenti, PROV-VE-DI-MEN-TI. Ripulirono il pavimento con pale e scope, e io appresso a loro a gettare i vuoti.
«Andiamo a buttare questa monnezza alla campana del vetro» e io pensai a un’enorme torre di cristallo con una grande campana che faceva il suono delle collane colorate di mamma quando le scuotevo. Mi portarono al mare con loro per una settimana e mamma non se ne accorse fino al giovedì, fino a quando le parve divertente sbraitare al telefono cose tipo “Io sono la madre”, in vestaglia forse, immaginandosi in uno di quei film anni Sessanta con le attrici vestite di sottane svolazzanti, forse. Sfatta forse.
“Riportatemi mio figlio”. Senza che le importasse davvero di me, forse.
Quando tornai da lei, ormai conoscevo solo il sapore della sabbia infilata sotto le unghie. Mi piaceva quel gusto salato, lo cercavo dappertutto e lo trovavo ancora più forte nel dado per la minestra. Ne scartavo l’involucro argentato e lo succhiavo per intero, lo scioglievo facendomi salire il morso di sale nelle cavità delle orbite, e un po’ bruciava la gola. Mi bastò fino a quando non iniziai a leccare le batterie per sentire la piccola scossa che speravo, a ogni giro, pizzicasse più forte. Dovevo nasconderle: tenevo le pile più scariche per la mattina nella casa sgabuzzino, e quelle nuove sotto il cuscino, per dormire.
La notte. La notte.
Ricordo un pomeriggio di luglio con mamma e nonna a casa di una signora all’ultimo piano di una palazzina verde. Nella stanza semibuia lunga quanto la galleria di un lombrico i pochi spiragli di luce sembravano disegnare un alfabeto Morse sulle tapparelle abbassate. Io seduto a terra vicino ai sottovasi che covavano larve di zanzare, le guardavo parlare. La signora iniziò a scrivere piano, pinzava la biro con due dita, guardava mamma, taceva, annuiva e scriveva senza stare nelle righe, poi incalzava: un corsivo impazzito, faceva grossi cerchi senza mai staccare la mano, bombe di ghirigori, roteava il polso, il gomito non staccava dal foglio, uno scarabocchio enorme, il cane enorme là fuori, gli occhi enormi zeppi di carbone, scacciava Serafina, biascicava le parole, mamma piangeva, e le mie sbucciature sulle ginocchia sapevano all’improvviso di dado, di batterie, di pangrattato, di occhi di pesce, di me, di papà.
Il giorno in cui portarono via mamma, portarono via anche me. Ma non di notte, le ladre di bambini.
«Quel ragazzino» sbraitava lei divincolandosi, «quel ragazzino ha bisogno di una bella drizzata» ed è così che mi salutò mentre le signore con la cartellina azzurra mi accarezzavano il viso, chiamandomi tesoro, mettendomi una mano sulla spalla. La spalla destra, quella che qualche anno dopo caricava il sacco di farina con un movimento brusco e lo svuotava nell’impastatrice del panificio. Girava, girava, la notte. La notte impastava tutto, sommessa, e non potevo sbagliare il pane per il giorno dopo. Notti senza ore, cortei di blatte e il serpeggiare dell’edera che si arrampicava sul muro. Gattacci in calore, farina scivolosa, maglietta bianca, impasto che non tirava, rimpianti del giorno. L’alba scandiva le infornate di biscotti, le cordicelle della moschiera battevano sul vetro della porta e sulle incertezze di Elide, la proprietaria del panificio, dettate dai conti, dalle tasse e dai meschini che passavano ogni due mesi a prendersi la loro parte. Li vedevo di notte, passavano a chiedermi se andava tutto bene, se avevo bisogno di qualcosa.
La notte, la notte.
Smisero di venire quando Elide tardò con la loro parcella: la farina costava di più e pure il burro, e io capii che il pizzo, lei, ce lo aveva ricamato sulla pelle, non soltanto sulla biancheria. Alle domande che mi facevo nello sgabuzzino con il dado appiccicato ai denti, anni prima, rispondeva un destino che è quello di adesso.
Il negozio è stato bruciato, e ora la notte, la mia notte insonne, la passo dal benzinaio, a guardarla da vicino, l’unica signorina luccicante rimasta.
Vorrei seguirla quando se ne va per scoprire se dorme al cimitero degli elefanti, come lo chiamavamo io e papà quel posto in cui demolivano le carcasse delle macchine incidentate. Vorrei averla per le mani, girarla e capire com’è fatta, capire se è davvero così facile spegnere una lucciola. Voglio vedere come si muore, se quando succede zampilla il sangue da qualche parte, dalle orecchie, dalla bocca, dai suoi buchi. La spellerei piano, donna nespola, il primo velo di pelle dorata, zingara serba, e i suoi occhi cervoni più grandi dei seni. Vorrei mischiarle i pezzi della faccia e sistemarli a caso per tutto il corpo, cancellare le coordinate dei suoi fianchi, lì dove sta appeso quel filo di mutanda che la rende umana, vera, molto più fragile di quel ricordo d’infanzia quando c’era ancora mio padre. Vorrei sbucciarla da capo a piedi della carne che abita il suo corpo. Se lo facessi smetteresti di esistere ancora di più? Vorrei sfrangiarle i capelli, le ciglia degli occhi vuoti e sarebbe ancora più glabra di adesso, lei e la sua anima sbiadita. La scucirei della trama di lentiggini e lascerei lì la polpa viva sotto la maschera ad asciugare. Lo farei per il suo bene. E per tutto il mio male.
La guardo ogni notte aspettare, grattare, limare le unghie e buttare a terra i residui di qualcosa, granate di cheratina. La guardo che alza la testa al passaggio di un paio di fari che non cercano lei. Riabbassa gli occhi e getta via i rimasugli, scocciata, riprendendo a limare con una lima diversa, con un tormento diverso. É assorta, è concentrata, conta qualcosa, le pellicine? A volte si siede sullo scalino nella sua aiuola di cemento, di fazzoletti usati e cicche consumate, ogni notte con una targa diversa, e dopo che lo ha fatto, dopo che ha sputato la saliva nell’angolo, seguo le sue mani piccole ficcarsi in bocca la solita manciata di mentine per poi continuare a limare, a limare, a limare. Lo fa fino all’arrivo del cliente successivo, certe volte esala un gemito di rassegnazione quasi che non abbia più nulla da accorciare. Quando la piazzola resta vuota, ho finalmente una mezz’ora per frugare nella sua borsetta dimenticata e trovare a sorpresa una miriade di biglietti grattati, e scoprire che la lima non è nient’altro che una moneta che raspa su schedine dorate, su file di simboli che potrebbero cambiarle la vita.
Mele, fragole, cocchi, diamanti, stelline, coppe, quadrifogli e ciabatte infradito. E allora, nel buio della notte – la notte – spero che almeno lei, tra tutte quelle schegge argentate di Madreperla, possa trovarci un disegno fortunato.
A illustrare: una fotografia di Antoine D’Agata, fotografo Magnum.