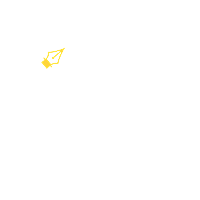Scintillante blu
Nei giorni scorsi ho sognato che ti avevo accompagnato a comprare le scarpe. Scarpe da vecchio, comode – ma non troppo brutte. Il negozio era quello dei ricchi, luminoso, con i commessi gentili: si affacciava sul corso principale, sotto i portici – ci si andava nelle occasioni speciali.
Il negozio chiuse per sempre prima che io andassi via di casa. Tu sei morto da quasi quindici anni. Tu sei mio padre.
Mi piace quando ti sogno, pare che tu sia ancora vivo. Nei primi anni facevo sogni così vividi, con te che rientravi in casa la sera come se fosse tutto normale, che quando mi svegliavo non riuscivo a credere che la realtà fosse diversa. Ora non succede quasi più.
Stamattina mi sono svegliato mentre stavo per comprare un maglione verde in un negozio olandese: ho aperto gli occhi prima di comprarlo davvero e sono ancora lì, ad aspettare che la commessa torni al bancone per darmelo. Ma io ce l’ho un maglione verde. E così l’ho indossato, perché oggi è un giorno speciale.
Quando sono uscito il cielo aveva un colore non definito: siamo ancora tra l’inverno e l’estate e ogni giorno ci sono entrambi, più volte. Alla fermata del bus, alcune persone hanno i piedi nudi dentro le ciabatte di gomma e altre indossano il piumino. Molti hanno scarpe sportive, alcuni quelle rosse che sono apparse qualche anno fa – con un marchio famoso vero o finto – tanto ormai è uguale. Ho sempre pensato che i piedi siano un aspetto significativo delle persone: quando sono nudi e indifesi, quando puoi vedere le dita così esposte in mezzo alla folla, sull’asfalto sporco del marciapiede, sulla gomma rigata del pavimento del bus, evocano fragilità e inconsapevolezza. Innocenza quasi; non puoi non preoccuparti per loro. Il mondo è un posto così difficile.
Tu non saresti mai uscito in ciabatte, con le dita nude che sporgono fuori, come fossi in spiaggia. Indossavi i calzini, le scarpe, il completo, la camicia, la cravatta a volte – e d’inverno anche il maglione, il cappello e il cappotto: ogni giorno, da casa all’ufficio e viceversa, a piedi. Mai i pantaloni corti. Mai i sandali. Mai le ciabatte. Mai. E certo non avresti indossato scarpe di plastica rosse.
Nei momenti in cui mi chiedo – ogni cazzo di giorno – se possiamo davvero essere felici, se ci sia felicità nella vita da larva che faccio, penso a come facevi tu, ad andare al lavoro la mattina e tornare a casa la sera, dalla famiglia, da me, dalla mamma: il giornale, il telegiornale, la cena, la televisione. E la mattina, ancora, il lavoro. E ancora e ancora. E il sabato la spesa tutti insieme al supermercato e poi la domenica, magari con gli amici – famiglie come la nostra – a volte a pranzo in trattoria e poi a giocare con i figli sui prati.
Sono i prati, la soluzione? Sono i figli? Una volta ti ho chiesto se non ti pesasse il lavoro, ogni giorno: ma tu dicesti che era normale, era il tuo dovere, era quello che facevi. Non mi viene nemmeno da ridere. È un ghigno. Se tu potessi vedere ora cosa è il lavoro, cosa è l’ufficio. Cosa sono quei prati.
Se avevi paura non ce l’hai mai detto. Se temevi il futuro, la vecchiaia, la malattia, la morte tua o delle persone amate. Ogni tanto parlavi di perdere il lavoro: era un evento lontano, improbabile, apocalittico. Come la guerra nucleare. Come un terremoto che abbattesse il palazzo dove abitavamo. Non ci avevo mai creduto davvero. Non conoscevo nessuno che avesse perso il lavoro; la guerra nucleare non mi faceva paura, era un mostro troppo grande – e i terremoti, dove abitavamo noi, erano leggenda.
L’inquinamento era il nuovo timore: inorridivo se trovavo un sacchetto di plastica abbandonato quando la domenica ci caricavi in macchina per andare nei boschi a raccogliere le castagne o le rose selvatiche o le more. A scuola scrivevamo temi sul pericolo della plastica, sui rischi che finisse in mare e negli oceani. Oggi la plastica è un oceano, è l’oceano. La penuria delle risorse era l’altra grande preoccupazione: le targhe alterne, la benzina che costa troppo, la benzina che non c’è. Il resto era passione politica (meglio l’assistenzialismo cattolico, il riformismo socialista o il rigore comunista?), speranza in un mondo migliore, risparmio e sacrificio per il futuro, fiducia nelle istituzioni, nello stato.
Non è rimasto niente di quel mondo.
Lo scorso anno mi hanno detto che castagne non se ne trovano, un insetto forse o una malattia degli alberi. Non credo che qualcuno sappia più che farsene, delle rose selvatiche. Le more si comprano nelle vaschette al supermercato aperto ventiquattro/sette; sono negli scaffali vicino alla frutta tagliata e sbucciata.
Adesso tutti hanno capito che i sacchetti di plastica sono il male perché sono a pagamento, anche i più piccoli per le verdure del discount – e io nei boschi non vado più, c’è troppa coda la domenica per uscire dalla città, troppe auto, troppa gente. La domenica dormo o sto al computer. Sui prati, bambini non ne vedresti comunque: si sporcano, si ammalano, si fanno male, nessuno ce li porta mai. Quando ci sono, si siedono per terra con il cellulare. Più facile che trovi dei cani.
Comunque io bambini non ne ho, non mi sentivo. Il futuro non lo vedo, non posso metterci dei bambini dentro. Non ho nemmeno un vero lavoro. Se tu mi chiedessi – figlio, che lavoro fai? – non saprei spiegarti. Sono ingegnere, mi immagineresti come capo-ufficio, una parola dimenticata. E invece non sanno nemmeno come mi chiamo. Vengo qui, ma il nome all’ingresso non è quello scritto sulla busta paga. Ecco, un altro termine obsoleto. C’è solo un bonifico alla fine del mese e, da qualche parte, quando funziona il sito, un pdf da scaricare. Siamo consulenti, collaboratori, lavoratori a progetto. Ai tuoi tempi si chiamava caporalato, magari. Oggi cambia nome di continuo. E poi non saprei mai spiegarti cosa faccio: è complesso, settoriale e probabilmente, in un’ottica globale, del tutto senza scopo. Ed è provvisorio: vengo qui per un certo tempo, con la mia laurea che non esiste nemmeno più, a fare un lavoro incomunicabile, ogni giorno sempre più inutile. A volte penso che la mia identità finta su Facebook sia più persistente di tutti gli altri aspetti della mia vita. Mi sento trasparente a me stesso, come in attesa di diventare più solido. Ma scomparirò, prima di comparire completamente.
Quando tu andavi in ufficio attraversavi quei fiumi di persone che entravano in fabbrica: mi dicevi di studiare che altrimenti dovevo “andare a lavorare”. Queste parole oggi suonerebbero incomprensibili: oggi il lavoro non c’è, sia che studi sia che non studi. Quelle fabbriche hanno chiuso tutte, comunque – e non sono tornate le spiagge che c’erano prima. Il mare è lì davanti, ma non puoi andarci: il mare ora lo immagini soltanto.
Tir, superstrade, container sono il paesaggio ora, e hanno inglobato ogni cosa. Ti trasferisti qui perché c’era il lavoro, le scuole, la stazione. Non è rimasto nulla; ma non è colpa tua. Sul tuo mondo sorgeva un sole diverso. A volte mi chiedo se riconosceresti qualcosa: se tu ritornassi ora, forse nemmeno capiresti – vent’anni sono duecento.
L’azienda dove vado a lavorare sorge in un’area ‘nuova’. L’area non è nuova, ovviamente, non esistono aree nuove: lo zio della mamma aveva un orto là, tu ci andavi spesso a dare una mano – ti piaceva coltivare, ti piaceva la terra. E mi portavi con te quando c’era da raccogliere le fave, le fragole, i piselli. Da piantare le patate. Da togliere le erbacce.
Adesso di erbacce ce ne sono così tante, capelli sulle creste dei cumuli di detriti lasciati indietro quando hanno sospeso i lavori: a fianco al nostro edificio dovrebbero sorgerne altri, con nuovi uffici e negozi, ma da anni non succede più nulla – c’è un problema di soldi – e tutto si è fermato là, nell’istante da dopo-bomba dei primi scavi. Ci sono solo tre torri, tre grattacieli quasi vuoti. In attesa. Come la mia vita.
Possibilità, idee, assurde fantasticherie, nemmeno potenzialità. Vite immaginarie, pensate soltanto. E intanto quello che succede davvero è che ogni giorno salgo qui, sulla collina calva e immobile: entro, mi siedo davanti al computer; poi torno a casa. Cambierà mai qualcosa?
A volte salgo all’ultimo piano. C’è una grande terrazza che non si raggiunge con l’ascensore, perché l’ascensore porta solo ai piani affittati – dove ci sono gli uffici – e l’attico non l’ha ancora richiesto nessuno. Ma si può salire a piedi e, dopo tutte quelle scale, si può aprire la porta di sicurezza e camminare sulle lastre nuove scintillanti blu scintillanti lucide – uno specchio del cielo, un piccolo mare quadrato, brillante – fino a quel bordo nero di ardesia, un orlo tagliente di scogli. E intorno gli uccelli, gabbiani e qualche falco: scendono dalla rocca vicina, volteggiano intorno alle torri, scendono in picchiata – e risalgono. Adoro guardarli. Il loro volo è così ipnotico, riesco a non pensare più; e nello stesso tempo è così reale, così vivo: finalmente mi sento vivo anche io.
Ogni giorno salgo qui, sulla collina calva e immobile: entro, mi siedo davanti al computer; poi torno a casa. Oggi però sarà diverso. Oggi imparerò a volare.
Foto dell’autrice del racconto