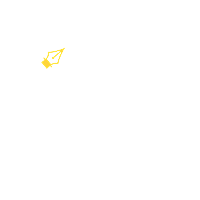Il fiore del bonsai
Piove. Le gocce scendono veloci lungo il vetro della finestra, ognuna di loro scandisce il tempo che passa e passa, ma non passa mai. L’attesa mi scivola sulla pelle, la sento formicolare come un pensiero fantasma che si dipana dal mio cuore e dalla mia mente. Sto bene laggiù, mi ci sono abituata. Qui, invece, non ci resisto. C’è troppa luce, mi fa ammalare. Una luce denudante, inaccessibile. Rivela ogni cosa e la nasconde; ogni tanto cambia e allora avverti il tempo che passa e passa, ma non passa mai. L’immobilità mi attraversa, mentre laggiù sono io ad attraversarla. Un corpo che trema: il mio. Lento come un sospiro che non ha il coraggio di finire, per paura di fare troppo rumore.
«Questa pianta non fiorisce più.»
La mamma è seduta lì, al tavolo del nostro monolocale. Pota il suo bonsai di melograno, mentre il televisore riempie col brusio un silenzio che non sappiamo più colmare.
Mia madre è triste perché sono anni che quella pianta non fa fiori e, nel tempo, tutto è diventato più complicato.
«Credo sia per il sole, non gli arriva più» mi dice, tagliando un piccolo ramo. «Vorrei cercare una casa nuova. Una con il terrazzo grande o il giardino. Sarebbe bello, no? Ti piacerebbe?»
«Certo» le rispondo guardandola.
«Solo che è complicato, lo stipendio basta a malapena per questo posto. Io non so fare nulla… prima c’era tuo padre che pensava a tutto.»
«Non è vero che non sai fare nulla, mamma.»
«La signora Paulopoulos mi ha offerto un lavoro in conceria. Non sono molto brava, ma con un po’ di pratica… è una donna davvero cara.»
«Dovresti accettarlo.»
«Magari fino alla prossima primavera.»
«Non pensare alla prossima primavera» dico tornando a guardare fuori dalla finestra. Il brusio del televisore disturba ancora i nostri pensieri. Mia madre è triste: oggi è l’ultimo giorno. E piove.
«Avrei voluto ci fosse il sole» mi dice senza guardarmi. «Saremmo potute andare nei campi, fra gli alberi di melograno. In questo periodo sono in fiore.»
Si ferma con le forbici a mezz’aria, voltandosi verso di me mentre fingo di concentrarmi sulle gocce di pioggia. In realtà, la guardo attraverso il riflesso della finestra. «Se tu non partissi domani» continua, «potremmo sperare che sia una bella giornata. Stare fuori, mangiare la marmellata di fichi e poi scappare dalle vespe che cercano di rubarcela, come facevamo quand’eri più piccola.»
«Le vespe sono fasciste», le dico.
«Sono un po’ aggressive, però mi farei attaccare da uno sciame di vespe tutti i giorni, pur di stare con te.»
«Sarebbe doloroso.»
«Le vespe o stare con me?»
Continuo a guardare le gocce che scendono lungo il vetro della finestra. Le immagino vetture di tanti microscopici piloti. La goccia di destra sta per superare quella di sinistra ma ce n’è una, nel punto più lontano del vetro, che recupera velocemente. Nessuno bada a lei, lì, sola e isolata. Nessuno bada al suo scendere veloce, sempre più veloce, supera la prima goccia, la seconda, ed ecco che vince!
«Oh, mi rispondi o no?» mi chiede mia madre che non ha mai smesso di fissarmi.
«Scusa, mi sono distratta.»
«Ti distrai sempre alle domande importanti.»
«Non esistono domande importanti.»
«A cosa pensavi?»
«Posso distrarmi di nuovo?»
Questa volta sono costretta a voltarmi e sorridere. La guardo, è invecchiata. Mi scruta con i suoi occhi stanchi e per la prima volta penso che non sarà lì per sempre. Mi fa pena, ma anche rabbia. Non sopporto quando mi chiede a cosa stia pensando. Non penso mai a niente. O almeno a niente che le voglia raccontare. Lui è qualcosa che rimane solo nei miei pensieri, qualcosa che lei vuole conoscere e che io, però, non posso condividere. Non voglio condividere.
«Non pensavo a niente» dico, «mi ero persa a guardare la pioggia.»
«È la prima volta che l’ultimo giorno piove.»
«È già capitato, tempo fa.»
«Non me lo ricordo.»
«Sono passati tanti anni.»
«Quanti?»
«Non lo so» rispondo, mentendo.
Li ricordo tutti gli anni con lui. Ricordo il nostro primo incontro. Il vento caldo di fine estate mi bruciava la pelle e migliaia di stelle sottilissime lampeggiavano con colori a cinque raggi, una per ogni capello. Le vedevo nell’acqua fresca del mare, brillavano infinite intorno al mio viso, come avessi preso fuoco, come se volessi gettarmi sulla mia immagine liquida per spegnerlo. D’improvviso le acque cominciarono a incresparsi e con loro il mio riflesso. Tutta la Terra iniziò a tremare senza rompersi, delicatamente, come i terremoti nel cuore degli amanti quando si scambiano il primo bacio. Nel moto armonico delle onde, solo due stelle rimasero chiare e distinguibili, nere e profonde come la notte prima dell’alba: quelle stelle erano i suoi occhi: la grande certezza oscura.
Gridai, non di paura ma per il senso di piacere. Gridai per la luce scura che mi avvolgeva, morbida e dolce. Gridai perché, per una volta, una luce mi nascondeva. Forse è per questo che alla fine scegliamo l’ombra. L’oscurità è nera, liscia, inalterabile e senza sfumature. Ti evita lo sforzo di distinguere e di farti distinguere.
«Lo hai fatto di nuovo» mi dice mia madre con una nota di delusione nella voce. «Sono le ultime ore che stiamo insieme e tu sei già laggiù.»
La sua voce trema e i suoi occhi a malapena trattengono le lacrime. Vorrei rassicurarla, dirle che si tratta solamente di un periodo e che, tempo sei mesi, sarò di nuovo da lei, ma so di non poterlo fare. So che, questa volta, chiederò di restare lì per sempre, con lui, nella libertà oscura.
Laggiù le case sono silenziose, occhi vuoti su strade semideserte. I fiumi sono immobili e il cielo è così grave che nessuno pretende risplenda. Nessuno pretende niente. C’è qualche raro pioppo cinereo, i cipressi ombrosi che ricoprono le valli, la menta selvatica inodore e alcuni melograni. Lui mi sbuccia i frutti di quegli alberi con le sue mani. Le sue dita grandi diventano ancora più nere. I chicchi risplendono fiocamente come fialette di vetro piene di sangue. Mi dà da mangiare nella sua mano perché non mi scordi di tornare ancora da lui. Come potrei? Il melograno di mia madre, quello, non fiorisce più e non dona più frutti. Forse aspetta che io discenda per sempre. Vita alla vita, morte alla morte. Un fiore per una coscienza.
«Persefone!»
Mia mamma mi guarda, ora, piena di rabbia. Avevo dimenticato come suonasse il mio nome tra le note della sua voce. La guardo e altri ricordi si affollano nella mia mente. Il mare, le case bianche sulla costa, l’ombrellone a righe rosse e gialle che viene portato via dal vento e lei che corre gridando «Aiutami, Persefone! Non lo vedi che vola via tutto quanto?»
Siamo sempre state io e lei, sole e insieme in ogni estate della mia esistenza: un flusso di luce e ombra. Ma adesso, in questo piccolo monolocale di periferia, mi rendo conto di come quei momenti di luce non fossero altro che attimi effimeri, illusioni di una vita che non c’è mai stata. Il tempo si è sgretolato fra le mie mani, mia madre è invecchiata e io sono rimasta una bambina, quella bambina che lui ha trascinato con sé nell’Ade.
«Sei arrabbiata» le dico.
«E allora?»
«Non dovremmo parlare quando siamo arrabbiati.»
«Cosa dovremmo fare?»
«Stare in silenzio, vicine. Solo tu e io.»
Un tempo ci credevo davvero: solo lei e io, non serviva altro. Non bastiamo mai ai nostri desideri e il desiderio non ci basta. Rimane la stanchezza, la rinuncia, il sudore e il distacco. Finché, infine, arriva la notte a spegnere ogni cosa e a confondere tutto.
«Vieni qui» le dico.
Mia madre mi guarda, la guardo. «Ti prego» aggiungo.
Lei appoggia sul tavolo le piccole forbici da potatura e si sdraia nel letto vicino a me. Ha scelto lei di metterlo sotto la finestra per farmi godere del sole che, quando sono laggiù, non riesco neppure a ricordare. Forse è proprio questo il problema: del buio non ti dimentichi mai, della luce sì. Lei lo sa bene. Mi stringe. Ha paura.
«Non andare» mi dice con una sicurezza che non ha.
«Non posso, mamma. Lo sai.»
«Lui ti piace?» mi chiede.
Distolgo lo sguardo. Annuisco.
«Stai meglio con lui che con me?»
Rimango in silenzio.
«Non tornerai più?»
Non lo trova giusto, ma ha la dolcezza di non dirmelo. Mi abbraccia.
«Sei la mia bambina» mi dice. «Ti canto una canzone, ti va? L’ultima ninnananna, come quando eri piccola.»
Annuisco sperando con tutta me stessa di provare qualcosa, ma l’unica cosa che si muove dentro di me è il desiderio di nascondermi nell’abbraccio delle ombre. Mia madre inizia a cantare un vecchio canto greco. Parla di prati fioriti e di uomini valorosi di altri tempi. Io resto ad ascoltarla, in silenzio, quasi trattenendo il fiato per la paura di fare troppo rumore. Il mio corpo è un’implosione di forze contrapposte e sono sfinita. Mia madre sembra rendersene conto e addolcisce il suo canto. Un lamento. Un sussurro. Il silenzio. «Chiudi gli occhi» mi dice.
E io li chiudo. Lascio finalmente andare il mio respiro. Lascio finalmente andare il mio corpo. Mi lascio finalmente andare. L’ultimo ricordo è un piccolo fiore rosso sul bonsai che giace sul tavolo.
Illustrazione di Irene Masi